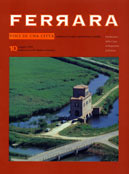I magnifici giardini del Castello, con il padiglione dalle colonne marmoree, i pavimenti a intarsi colorati, le fontane, i fiori e i frutti, descritti da Sabadino Degli Arienti nel 1497, sono da mettere in relazione alla colta rilettura di un modello medievale che ebbe grande fortuna per tutto il Rinascimento: il "giardino per un re" tratto dall'opera di Pier De' Crescenzi.
Nei giardini del Pavaglione del Castello sono chiaramente ripresi dallo schema letterario la disposizione regolare con padiglione al centro, i percorsi ortogonali e le aiuole a disegni geometrici colme di fiori, piante officinali, frutti ed ortaggi.
 Anche il giardino della delizia di Belfiore, dove Lionello aveva fatto dipingere le famose Muse per il suo studiolo, mostrava una disposizione di questo genere. Tale organizzazione era mantenuta ancora nella seconda metà del Cinquecento, secondo quanto ci comunica una pianta recentemente riemersa dagli archivi.
Anche il giardino della delizia di Belfiore, dove Lionello aveva fatto dipingere le famose Muse per il suo studiolo, mostrava una disposizione di questo genere. Tale organizzazione era mantenuta ancora nella seconda metà del Cinquecento, secondo quanto ci comunica una pianta recentemente riemersa dagli archivi.
Agli archivi è infatti affidata la memoria di queste fragili opere dell'uomo e della natura, che sono rapidamente decadute dopo la devoluzione del 1598 e, quindi, destinate all'oblio.
Ma il ricordo di tali meraviglie doveva essere nonostante tutto molto forte, se ancora qualche decennio dopo la devoluzione dello stato estense al papato i fasti dei giardini ducali venivano ricordati e doviziosamente descritti dal cartografo Alberto Penna e dallo storico Marc'Antonio Guarini.
E' lecito supporre che i modelli ferraresi fossero conosciuti ed apprezzati anche fuori dal ducato: si pensi all'ammiratissimo giardino di Montecavallo in Roma - ora Quirinale - dove, attorno al 1550, Ippolito II d'Este, detto il "Cardinal Ferrara", aveva fatto disporre la sua straordinaria collezione di antichità dall'architetto e pittore ferrarese Girolamo Da Carpi.
 Lo stesso capolavoro del Cardinale, il giardino di Villa d'Este a Tivoli, unico superstite fra almeno cinque giardini commissionati da Ippolito, fu allestito secondo il progetto dell'antiquario romano Pirro Ligorio attorno agli anni 1560. Tuttavia questa famosa invenzione, carica di complessi significati simbolici atti a comporre una sorta di percorso iniziatico, sembra avere un precedente significativo in un giardino ferrarese scomparso: il giardino della Montagna di Sotto, impropriamente noto come "Bagni Ducali", realizzato fra il 1541 e 1555.
Lo stesso capolavoro del Cardinale, il giardino di Villa d'Este a Tivoli, unico superstite fra almeno cinque giardini commissionati da Ippolito, fu allestito secondo il progetto dell'antiquario romano Pirro Ligorio attorno agli anni 1560. Tuttavia questa famosa invenzione, carica di complessi significati simbolici atti a comporre una sorta di percorso iniziatico, sembra avere un precedente significativo in un giardino ferrarese scomparso: il giardino della Montagna di Sotto, impropriamente noto come "Bagni Ducali", realizzato fra il 1541 e 1555.
A Ferrara, lungo il viale Alfonso II d'Este, alcuni labili segni indicano ancora la passata esistenza di questo giardino allegorico - celebrativo, costruito per volontà del duca Ercole II. Elementi principali del giardino erano la montagna, entro la quale erano scavate due grotte, il palazzetto, quasi una citazione della domus romana, che ora sopravvive privo di tutte le decorazioni pittoriche, il giardino geometrico, il boschetto, la fontana e il labirinto, la peschiera e i pergolati.
La contrapposizione fra montagna, grotta e selva da un lato e giardino "geometrico" e palazzetto dall'altro potrebbe alludere al tema di Ercole al bivio fra vizio e virtù, precipuo significato morale del giardino di Villa d'Este.
Il labirinto rappresenta la difficoltà dell'itinerario di Ercole mentre la montagna «piantata di vigne pretiosissime» è riferita, come Parnaso, all'Ercole Musagete assimilato a Dioniso, di cui narra Plinio, autore studiato da Celio Calcagnini e in seguito anche da Pirro Ligorio.
 La raffinatezza di questa invenzione, alla quale certamente contribuirono Girolamo da Carpi e il colto umanista ferrarese Celio Calcagnini, si può apprezzare in uno degli splendidi arazzi della serie delle Metamorfosi, intessuto per il duca Ercole II da Giovanni Karcher su cartone dei Filippi nel 1545. L'arazzo, ora al Louvre, rappresenta con attendibile fedeltà, come ha riconosciuto lo studioso Felton Gibbons, la topografia del perduto giardino della Montagna di Sotto.
La raffinatezza di questa invenzione, alla quale certamente contribuirono Girolamo da Carpi e il colto umanista ferrarese Celio Calcagnini, si può apprezzare in uno degli splendidi arazzi della serie delle Metamorfosi, intessuto per il duca Ercole II da Giovanni Karcher su cartone dei Filippi nel 1545. L'arazzo, ora al Louvre, rappresenta con attendibile fedeltà, come ha riconosciuto lo studioso Felton Gibbons, la topografia del perduto giardino della Montagna di Sotto.
Se quasi nulla rimane, dopo secoli di oblio e distruzioni, dei famosi giardini estensi, non si può d'altra parte ignorare come anche il patrimonio di verde storico più recente soffra a causa di una evidente mancanza di quella manutenzione attenta e continua necessaria alla conservazione di queste "opere d'arte viventi".
I parchi Massari e Pareschi, in cui l'impianto ottocentesco è ancora chiaramente leggibile, nati come parchi privati e sottoposti da decenni a un intenso uso pubblico, mostrano infatti una improrogabile necessità di manutenzione, alla quale il comune intende provvedere a breve. In questi parchi pubblici, come anche in diversi bei giardini privati, sarebbe necessario intervenire con grande attenzione, seguendo criteri di restauro, da preferire a pericolose quanto vaghe "risistemazioni" che rischiano in alcuni casi di ignorare o cancellare le stratificazioni storiche in nome di un non meglio definito valore d'uso.
In questi parchi pubblici, come anche in diversi bei giardini privati, sarebbe necessario intervenire con grande attenzione, seguendo criteri di restauro, da preferire a pericolose quanto vaghe "risistemazioni" che rischiano in alcuni casi di ignorare o cancellare le stratificazioni storiche in nome di un non meglio definito valore d'uso.
E' relativamente recente l'attenzione verso il giardino inteso come bene culturale: la carta del restauro, documento fondamentale per la conservazione di parchi e giardini storici, redatta a Firenze nel 1981, prescrive che questi manufatti siano trattati con la stessa attenzione destinata alle altre opere d'arte.
Da questa data fondamentale molto è stato fatto a livello di studi e formazione scientifica, ma molto resta ancora da fare per la diffusione di queste preziose acquisizioni e professionalità.
Negli ultimi anni a Ferrara le associazioni culturali hanno promosso una nutrita serie di attività che confermano un nuovo e non marginale interesse dei cittadini verso il problema del verde storico.
 Il recupero dei sagrati, curato dalle associazioni Garden Club e Ferrariae Decus con la Circoscrizione centro cittadino, rappresenta un importante contributo per un particolarissimo tipo di verde pubblico che forse rischiava di essere trasformato in posti auto e che comunque, così com'era, in stato di abbandono e degrado, dava una percezione negativa e sgradevole dell'intorno.
Il recupero dei sagrati, curato dalle associazioni Garden Club e Ferrariae Decus con la Circoscrizione centro cittadino, rappresenta un importante contributo per un particolarissimo tipo di verde pubblico che forse rischiava di essere trasformato in posti auto e che comunque, così com'era, in stato di abbandono e degrado, dava una percezione negativa e sgradevole dell'intorno.
Rilevante e di grande civiltà l'apporto dei singoli cittadini per la manutenzione di questi sagrati, di cui diventano gli orgogliosi custodi e difensori. Fra gli altri ricordiamo i sagrati di San Francesco, San Girolamo e Santa Maria della Consolazione, al cui misurato e attento recupero si deve un generale e diffuso miglioramento di tutte le aree urbane circostanti.
A Ferrara il ricordo dei giardini rinascimentali sopravvive in forma per così dire traslata, ed è affidato ai giardini, di impianto novecentesco, di due prestigiose residenze di epoca estense, ora adibite a uso pubblico: si tratta di palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro, ora Museo Archeologico Nazionale, e della palazzina di Marfisa d'Este, attualmente sede di museo comunale.
 Il recente lavoro di manutenzione operato dal Garden Club nel giardino palazzo Costabili ha riportato in luce la piacevole creazione "in stile", progettata intorno agli anni Trenta, in occasione del primo allestimento del Museo di Spina. In questo piccolo giardino si ritrovano tutti gli elementi della tradizione rinascimentale, ovviamente stilizzati secondo il gusto tardo liberty e senza troppe preoccupazioni filologiche: il labirinto di bosso, i tassi potati a forma di piramide (ora a cono), il pozzo, i pergolati di rose, le aiuole geometriche con bulbi e fiori.
Il recente lavoro di manutenzione operato dal Garden Club nel giardino palazzo Costabili ha riportato in luce la piacevole creazione "in stile", progettata intorno agli anni Trenta, in occasione del primo allestimento del Museo di Spina. In questo piccolo giardino si ritrovano tutti gli elementi della tradizione rinascimentale, ovviamente stilizzati secondo il gusto tardo liberty e senza troppe preoccupazioni filologiche: il labirinto di bosso, i tassi potati a forma di piramide (ora a cono), il pozzo, i pergolati di rose, le aiuole geometriche con bulbi e fiori.
Il lavoro di manutenzione del Garden Club è avviato anche presso la palazzina di Marfisa d'Este, dove il giardino e i campi da tennis furono progettati insieme da Girolamo Savonuzzi, in occasione dei restauri del 1938 che riconsegnarono a Ferrara la palazzina, ampiamente quanto garbatamente ricostruita. Anche questo è un giardino in stile neorinascimentale ormai storicizzato e che quindi merita le migliori attenzioni.
 Questi due piccoli giardini, certo modesti se confrontati alla tradizione ferrarese del Rinascimento, assumono comunque una importante funzione evocativa che nel tempo ha rafforzato il rapporto fra architettura e giardino, tanto che ora riesce difficile pensare l'una senza l'altro.
Questi due piccoli giardini, certo modesti se confrontati alla tradizione ferrarese del Rinascimento, assumono comunque una importante funzione evocativa che nel tempo ha rafforzato il rapporto fra architettura e giardino, tanto che ora riesce difficile pensare l'una senza l'altro.
Anche il ritorno delle piante di agrumi nel giardino pensile del Castello estense è un episodio significativo di questa piccola rinascita del verde storico di Ferrara: in occasione dei recenti restauri sono state infatti spostate le esotiche palme che arredavano lo spazio incantato e sospeso sulla città e al loro posto sono tornate le mitiche esperidi, tanto legate ai fasti estensi, collocate entro vasi in terracotta appositamente fabbricati.
Nella topografia del verde ferrarese restano, comunque, almeno due punti dolenti: Piazza Ariostea e i giardini di viale Cavour. Entrambi i luoghi, infatti, presentano una cattiva manutenzione generale del verde, della pavimentazione e degli arredi, certo non adeguata all'importanza, sia storica sia attuale, dei luoghi.
 In particolare i giardini di viale Cavour, che per una sorta di terribile contrappasso si trovano a corrispondere con una parte dell'antica topografia dei giardini del Castello di epoca estense, si presterebbero bene a un progetto contemporaneo di qualità più che a una semplice manutenzione.
In particolare i giardini di viale Cavour, che per una sorta di terribile contrappasso si trovano a corrispondere con una parte dell'antica topografia dei giardini del Castello di epoca estense, si presterebbero bene a un progetto contemporaneo di qualità più che a una semplice manutenzione.
La recente pubblicazione, patrocinata da AGEA, di un volume di saggi dal titolo I giardini di Ferrara, la giornata di studio sul giardino di palazzo Costabili e quella sul giardino storico promosse dalle associazioni culturali, le recenti realizzazioni dell'assessorato all'ambiente del Comune di Ferrara, sono tutti indicatori rilevanti di questo rinnovato interesse della città nei confronti del proprio patrimonio di verde storico.
Anche la provincia sembra risentire di questo clima, infatti il Comune di Voghiera, nel cui territorio si trova oggi buona parte di quella che fu la magnifica delizia di Belriguardo, intende promuovere in un prossimo convegno lo studio del grande giardino di questa residenza estense, del quale sopravvivono ancora i tracciati dei canali di alimentazione delle grandi peschiere e dei giochi d'acqua.