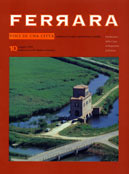Davanzati, Serra, Montanari, Broggia, Galiani rappresentano solo gli esponenti più noti di una lunga tradizione di studi sulla moneta cui contribuisce anche una folta schiera di scrittori minori. I disordini monetari dell'epoca costituivano certo materia di riflessione. La loro origine era prevalentemente fiscale. Dagli albori della coniazione, i governi avevano individuato nel signoraggio una fonte di entrata cui far ricorso in circostanze eccezionali.
Come ricorda Galiani (Della moneta, libro III, cap.VI), all'indomani della prima guerra punica il peso dell'asse fu ridotto a un sesto di quello originario per rimborsare il debito pubblico. Ma l'interferenza del principe nel sistema monetario era dovuta, secondo Keynes (Tract on Monetary Reform, 1923, pp. 161-3), anche al modus operandi del meccanismo di aggiustamento nel commodity standard. In presenza di prezzi e salari rigidi, un deflusso di oro si rifletteva negativamente sul reddito e sull'occupazione. L'intervento del sovrano sulla quantità di moneta può essere, quindi, interpretato come il mezzo per contrastare gli effetti deflazionistici di tale processo.
 Indipendentemente dalla loro origine, questi interventi, cumulati nel tempo, finiscono per compromettere le funzioni della moneta e, in particolare, quella di unità di conto. L'importanza del trattato di Scaruffi sta nel tentativo, forse il primo, di eliminare i maggiori costi di transazione generati dalle manipolazioni monetarie, che inficiano il ruolo essenziale della moneta di produrre informazione. Scaruffi, uomo "pratico", incontra questa problematica nella sua attività di mercante e propone di uniformare lo standard.
Indipendentemente dalla loro origine, questi interventi, cumulati nel tempo, finiscono per compromettere le funzioni della moneta e, in particolare, quella di unità di conto. L'importanza del trattato di Scaruffi sta nel tentativo, forse il primo, di eliminare i maggiori costi di transazione generati dalle manipolazioni monetarie, che inficiano il ruolo essenziale della moneta di produrre informazione. Scaruffi, uomo "pratico", incontra questa problematica nella sua attività di mercante e propone di uniformare lo standard.
In un sistema metallico, il rispetto delle due regole fondamentali, fissare l'unità di conto e mantenere la libertà di coniazione, conduce a un'unione monetaria de facto. Perciò John Stuart Mill (Principles, libro III, cap. XX) stigmatizza l'uso di monete nazionali definendolo un «barbarismo».
Questa proposizione si inscrive in una visione classica fondata sull'ipotesi di equilibrio. In un commodity standard, la quantità di moneta si determina sul mercato della merce-moneta e, se le regole non vengono violate, il suo andamento sfugge al controllo dell'autorità.
Nel corso della storia monetaria, tuttavia, queste condizioni si sono di rado verificate, se non per periodi relativamente brevi e in circostanze particolarmente favorevoli, proprio per la loro difficile sostenibilità. Anche in epoche anteriori allo sviluppo della moderna politica monetaria, all'indomani della prima guerra mondiale, l'autorità monetaria interveniva per ridurre i costi di benessere derivanti da regole troppo rigide. È di notevole interesse, a questo proposito, il documento presentato da Alfredo Santini che illustra il parere sulla riforma ideata da Scaruffi da parte degli esperti nominati dal duca d'Este.
Questi ultimi, sottolineando le diverse caratteristiche dei sistemi monetari, suggeriscono che l'unione monetaria si può attuare solo se ciascuno Stato partecipante adotta le nuove regole, più stringenti, ed è in grado di sostenerne l'impatto «ma non già far prima degli altri regole che son per apportar gravi danni nel commercio con le altre città maggiori e dì maggior dominio che non hanno o non vogliono accettare questo insegnamento. E ciò può fare chi ha modo di sostenersi da sé come la Signoria di Venetia, di Milano, la Toscana, la Chiesa, la Spagna, l'Alemagna et simili, ma non già chi da sé solo non può mantenersi».
La rivisitazione del contributo di Scaruffi stimola un insieme di riflessioni utili per meglio inquadrare anche gli aspetti attuali del tema in questione. L'analisi dell'unione monetaria nei distinti contesti della commodity money e della fiat money permette, infatti, di enucleare gli elementi cruciali di questa problematica, quali la proprietà di riequilibrio del sistema economico e l'efficacia della politica monetaria, confermando il non trascurabile beneficio derivante dalla lettura dei classici anche per l'economista contemporaneo.
(Antonio Fazio è Governatore della Banca d'Italia)
Attualità di un progetto monetario
Mercante, campsor, monetarista: le attività di Gasparo Scaruffi hanno profondamente ispirato la sua opera. Quale momento più appropriato di questo, fra Europa ed euro, per ricordare la figura di un uomo del Rinascimento che cercò di mettere d'accordo principi e mercanti, esportazioni e mercati, monete grosse e monete piccole, realizzando e proponendo un disegno di unione monetaria?
Attualità della storia: Scaruffi sperava nella creazione di una "lira imperiale" comune a tutti gli Stati europei. Oggi, nell'Europa unificata, si realizza l'euro. Intorno alla vita e alle opere di Gasparo Vincenzo Scaruffi (1519-1584) ruota il saggio di Alfredo Santini L'unione monetaria nel Rinascimento (Corbo Editore, Ferrara 1999), che ripropone la modernità del mercante banchiere reggiano considerato (fra gli altri, anche dall'economista austriaco Joseph Alois Schumpeter) uno dei maggiori studiosi della moneta del XVI secolo, insieme a Jean Bodin e a Bernardo Davanzati.
Nella prefazione, l'autore tiene a precisare che il volume consiste in una «ordinata rilettura di testi e ricerche effettuate in varie epoche» suggeritagli dal senatore Guido Carli (1914-1993), che, dopo una chiacchierata di carattere, ovviamente, economico, gli lasciò un appunto sul retro di una fotografia: "Alitinonfo".
L'Alitinonfo - in greco "la vera luce", "il vero lume" - è l'opera che ha dato notorietà a Scaruffi, un uomo prevalentemente pratico, quasi illetterato, capace non solo di esporre, probabilmente con l'aiuto del giurista Piergiovanni Ancarani per quanto riguarda la forma letteraria, i rimedi a quello che egli definiva il "disordine monetario", ma di formulare un'analisi capillare e concreta di concetti che appartengono anche al nostro tempo, come lo scambio delle merci, il rapporto prezzi-salari, l'inflazione che danneggia tutte le categorie («ogni uno» scriveva Scaruffi, «giornalmente è sottoposto al danno, così il povero como il richo»).
 Scritta fra il novembre 1574 e il maggio 1579, l'opera venne stampata a Reggio, nel 1582, da Hercoliano Bartoli, con dedica al conte Alfonso Estense Tassoni, giudice dei Savi e consigliere particolare del duca di Ferrara, Alfonso II d'Este. Nel titolo completo di presentazione, il reggiano dichiarava esplicitamente l'intento della sua fatica: L'Alitinonfo di M. Gasparo Scaruffi regiano per fare ragione, et concordanza d'oro e d'argento, che servirà in universale tanto per provedere a gli infiniti abusi del tosare, et guastare monete, quanto per regolare ogni sorte di pagamenti et ridurre anco tutto il mondo ad una sola moneta.
Scritta fra il novembre 1574 e il maggio 1579, l'opera venne stampata a Reggio, nel 1582, da Hercoliano Bartoli, con dedica al conte Alfonso Estense Tassoni, giudice dei Savi e consigliere particolare del duca di Ferrara, Alfonso II d'Este. Nel titolo completo di presentazione, il reggiano dichiarava esplicitamente l'intento della sua fatica: L'Alitinonfo di M. Gasparo Scaruffi regiano per fare ragione, et concordanza d'oro e d'argento, che servirà in universale tanto per provedere a gli infiniti abusi del tosare, et guastare monete, quanto per regolare ogni sorte di pagamenti et ridurre anco tutto il mondo ad una sola moneta.
Nell'età moderna, epoca di attività finanziarie rinnovate e di commerci prosperi e sviluppati, si ritrova un'ampia trattatistica in tema di Zecca e di monete, sìntomo della necessità generalmente avvertita di disciplinare una materia così importante. Inserendosi, con il suo trattato, in questa fase di approfondimento, Scaruffi lasciava il segno, suscitando, in seguito, l'interesse di storici dell'economia e di ricercatori come Andrea Balletti, "scopritore" dell'economista reggiano su cui scrisse, nel 1882, Gasparo Scaruffi e la questione monetaria nel secolo XVI, e come gli studiosi intervenuti al convegno del 1984, dedicato dalla città di Reggio all'illustre concittadino, Gasparo Scaruffi. La vita e l'opera (a cura del Rotary Club Reggio Emilia).
Di questi interventi Alfredo Santini fa tesoro per condurre un'analisi - dilatata in un nutrito apparato di note - giocata fra la cronaca dell'epoca (il Ducato di Alfonso II d'Este dal 1559 al 1597) e le proposte di Scaruffi, tanto tenuto in considerazione da essere inviato, quale esperto ambasciatore, fuori e dentro il Ducato estense, a risolvere problemi di natura economico-finanziaria.
La molla che fece scattare in Scaruffi il bisogno di mettere sulla carta le sue riflessioni di una vita (L'Alitinonfo fu scritto in età matura) fu proprio l'esperienza delle missioni diplomatiche che gli diedero modo di toccare con mano, giorno dopo giorno, il problema della confusione monetaria e gli ostacoli che nascevano dalla circolazione di troppe monete diverse per conio e lega: disordine che si manifestava anche come elemento frenante del commercio, obbligando i reggitori degli Stati a incessanti negoziati e lunghe trattative.
È più volte sottolineato, nel saggio di Santini, che l'"operatore commerciale" Scaruffi visse in un periodo di «sconvolgimento dei prezzi, dove i rapporti di valore non rappresentavano più un imprescindibile termine di riferimento per gli scambi»; anzi, i mercanti erano chiamati quotidianamente ad affrontare questioni di difficile soluzione relative agli scambi commerciali».
Dopo aver tracciato il profilo della famiglia dei conti Baldicelli alias Scaruffi (mercanti nelle arti della «speciaria et merzaria... et in diverse altre mercantie», titolari di un banco di cambio, possidenti che gestivano i loro affari da un palazzo situato nell'antica piazza Grande di Reggio) e dopo avere descritto in breve la condizione economica in Europa e nel Ducato estense, considerando, in particolare, la posizione di Ferrara capitale e di Reggio, che dei territori estensi faceva parte dal 1290, Santini passa all'esame delle idee-guida e dell'importante trattato, puntando decisamente sull'argomento fondamentale e così attuale del progetto scaruffiano: la creazione di una "Zecca universale" che avrebbe risolto gran parte dei problemi attraverso l'emissione di una moneta unitaria circolante «nell'altre cittadi e provincie senza oppositione et impedimento alcuno», cioè, per dirla ancora con Scaruffi, «come se il mondo fosse una sola città e monarchia».
Uno dei motivi per cui il progetto del reggiano non andò in porto, sebbene i governanti a cui era stato sottoposto (Este, Farnese, Gonzaga) in linea generale fossero d'accordo con il metodo, va individuato nel fatto che egli, pur credendo e appoggiandosi alle istituzioni territoriali, prevedeva come garanti gli organismi maggiori, il Papato e l'Impero, in un momento in cui la loro decadenza era pressoché compiuta.
Lo studio di Santini è integrato da un'appendice documentaria in cui compaiono le lettere ritrovate da Marzio Romani presso l'Archivio di Stato di Mantova (Archivio Gonzaga), pubblicate a completamento del suo contributo al convegno di Reggio Emilia (Principi, alchimisti e scienziati: una "utopia" monetaria del Cinquecento): in queste lettere, scritte da Scaruffi nel giugno del 1568 al duca di Mantova, si riflette la genesi de L'Alitinonfo e delle idee che, maturando, hanno portato alla stesura del trattato.
 Oltre che a scopo documentario, vengono qui riproposte per permettere quel confronto fra stile letterario ed epistolare che, come si è detto, ha suggerito ad alcuni studiosi l'attendibile ipotesi che la revisione finale del trattato, prima della presentazione alla Corte di Ferrara, sia stata affidata a un'altra mano. Lo stesso trattatista, tuttavia, denunciava i suoi limiti in una lettera a Francesco Gonzaga: scusandosi per la poca chiarezza nell'esposizione dei concetti, precisava che non aveva mai «studiato libri per essere travagliato in altri negotij» e che, comunque, sarebbe stato meglio per lui «ragionarli a boca», cioè parlarne di persona. L'ultimo documento presentato in appendice (tratto dal citato scritto di Andrea Balletti) è, in pratica, la distinta, in data 28 maggio 1582, delle spese affrontate da Scaruffi per la stampa di cinquecentododici esemplari de L'Alitinonfo, dei quali quattrocento donati a diverse persone e i rimanenti, secondo gli accordi, rimasti allo stampatore.
Oltre che a scopo documentario, vengono qui riproposte per permettere quel confronto fra stile letterario ed epistolare che, come si è detto, ha suggerito ad alcuni studiosi l'attendibile ipotesi che la revisione finale del trattato, prima della presentazione alla Corte di Ferrara, sia stata affidata a un'altra mano. Lo stesso trattatista, tuttavia, denunciava i suoi limiti in una lettera a Francesco Gonzaga: scusandosi per la poca chiarezza nell'esposizione dei concetti, precisava che non aveva mai «studiato libri per essere travagliato in altri negotij» e che, comunque, sarebbe stato meglio per lui «ragionarli a boca», cioè parlarne di persona. L'ultimo documento presentato in appendice (tratto dal citato scritto di Andrea Balletti) è, in pratica, la distinta, in data 28 maggio 1582, delle spese affrontate da Scaruffi per la stampa di cinquecentododici esemplari de L'Alitinonfo, dei quali quattrocento donati a diverse persone e i rimanenti, secondo gli accordi, rimasti allo stampatore.
Da rilevare che un esemplare del trattato, mutilo del frontespizio e proveniente dalla Biblioteca dei Musei Civici di Arte Antica (nell'edizione Bartoli del 1582), è conservato dal 1985 nella Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, mentre un'altra copia è compresa in un'opera di Bernardino Pratisuoli, stampata a Reggio nel 1604, ancora da Hercoliano Bartoli (Considerazioni [...] sopra l'Alitinonfo de S. Gasparo Scaruffi, nelle quali con chiarissime ragioni si tratta delle cose delle monete). La fortuna del trattato è delineata attraverso la citazione di chi, in tempi a noi vicini, ha voluto individuarne nell'opera del mercante-economista il «primo trattato monetario dato alla scienza economica italiana» (O. Nuccio) e la «prima opera di economia pubblica italiana» (J. Griziotti Kretschmann).
Per concludere, sono presentate alcune note sulla monetazione di Alfonso II d'Este a Ferrara corredate dalle immagini delle monete estensi conservate nel Civico Medagliere del Museo Schifanoia di Ferrara. Il saggio di Santini, dunque, si articola attraverso un continuo e interessante intrecciarsi di problemi economici e di storia del territorio (Gian Maria Scaruffi, fratello di Gasparo, presentò a Corte un progetto di irrigazione nell'alta pianura reggiana che non fu mai realizzato), da leggersi anche attraverso le vicende dell'ultimo duca estense: ogni elemento concorre a contestualizzare efficacemente un trattato d'altri tempi, ma di sorprendente modernità.
Angela Ghinato