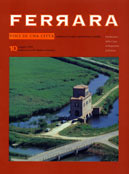Una indocilità dunque di temperamento che lo spinge a rivolgere le proprie curiosità intellettuali alla poesia, ma soprattutto alla pittura che non è certo una scelta consueta per i rappresentanti della classe nobiliare: una scelta immediatamente osteggiata dal padre. Fare il pittore di professione è una decisione singolare in una società d'antico regime, in una ex capitale come Ferrara scaduta al rango di appendice del dominio pontificio, in un luogo cioè che non sa sostituire il vagheggiamento di uno splendido passato con l'entusiasmo per l'incendio provocato dai "lumi", anche se qualche tenue bagliore arriva a rischiararne le nebbie.
Sarebbe stato più facile per esempio dedicarsi alla poesia, sull'esempio trasgressivo di Vittorio Alfieri; le lettere, si sa, hanno nella scala dei valori dell'antico regime una patente di nobiltà che non spetta alle arti visive e l'esempio dei conti Alfieri, Leopardi, Manzoni ne è una splendida riprova. Di questa inclinazione e scelta un intellettuale di gran peso come Niccolò Tommaseo tracciò un giudizio sprezzante; per lui Leopoldo Cicognara fece mediocri paesaggi, scrisse dei versi sulle ore, che passarono con esse.
E certo la fama del conte ferrarese non è affidata né ai corretti dipinti, di cui restano tracce nel paesaggio Treves, né tantomeno a poemetti come Il mattino, il mezzogiorno, la sera, e la notte o Le belle arti che rappresentano il frutto più maturo della sua attività poetica , tra il 1789 e il 1790, e che vanno visti semmai dentro una visione illuminista particolarmente attenta a ciò che accadeva nei centri più vivaci della cultura italiana: la pariniana Lombardia asburgica o la Napoli pre rivoluzionaria, vivace fucina di scelte filosofiche o ideologiche all'avanguardia.
 Nei giovanili viaggi - un grand tour italiano - a Roma e a Napoli incontra i rappresentanti più autorevoli della nuova stagione neoclassica e intreccia relazioni poetiche che lo porteranno, secondo la suggestiva tesi di una giovane studiosa del Cicognara, Francesca Fedi, ad aderire alla Massoneria.
Nei giovanili viaggi - un grand tour italiano - a Roma e a Napoli incontra i rappresentanti più autorevoli della nuova stagione neoclassica e intreccia relazioni poetiche che lo porteranno, secondo la suggestiva tesi di una giovane studiosa del Cicognara, Francesca Fedi, ad aderire alla Massoneria.
Questa scelta spiegherebbe il contrasto sorto tra Cicognara e il regime napoleonico al tempo dell'episodio forse più indicativo della sua carriera politica. Cicognara, ormai autorevole membro del Consiglio legislativo della neonata Repubblica italiana, sente in modo inquieto la progressiva destabilizzazione del giacobinismo, sempre più accentuata dal ritorno all'ordine voluto dal generale Bonaparte ai Comizi di Lione dove il suo avversario più autorevole è il Melzi d'Eril che garantisce una certa autonomia della politica italiana.
Cicognara, pur votando Melzi d'Eril, viene eletto dal presidente Bonaparte a membro del Consiglio. Nel 1802 un giovane capitano della Cisalpina, Giuseppe Ceroni, amico di Foscolo, invia a Leopoldo Cicognara il manoscritto di un poemetto, gli Sciolti di Timone Cimbro, in cui sotto la retorica del classicismo c'è una non troppo velata critica al governo francese, Cicognara risponde lodando l'autore e il Ceroni stampa alla macchia il poemetto, dedicandolo al Cicognara. Murat ordina una perquisizione in casa Ceroni dove vengono scoperte, tra le altre, le lettere di lode e del Cicognara e del generale Teullié.
Cicognara, nonostante la difesa del Melzi, viene imprigionato nel Castello di Milano, poi destituito ed esiliato. L'anno successivo Napoleone lo riabiliterà nel suo ufficio, ma la "ribellione" più intellettuale che pratica al potere napoleonico, indurrà il Cicognara di lì a poco a rinunciare alla carriera politica per dedicarsi allo studio e all'amministrazione, si direbbe oggi, dei beni culturali. Nonostante la grave frattura col potere francese Cicognara rimarrà sempre fedele all'ideologia rappresentata dalla grande Rivoluzione e, sostanzialmente, diverrà il massimo rappresentante dei valori culturali che la Rivoluzione e l'Impero imposero in Europa.
Perfino nella tarda stagione della sua vita, quando tramonta l'astro napoleonico e con lui tutta la cultura neoclassica, il Cicognara non abiurerà mai alle sue convinzioni ideologiche e non si piegherà mai a diventare l'intellettuale del potere austriaco; anche la sua partecipazione al nuovo movimento romantico rimase piuttosto esterna nonostante l'amicizia con l'uomo di punta del Romanticismo italiano, quel Gian Pietro Vieusseux, sulla cui rivista, L'Antologia, il vecchio Cicognara scrisse e pubblicò.
Ormai riscattato dai gravosi obblighi della politica attiva, Cicognara può dedicarsi invece agli studi filosofici che per il suo sempre più attento e perspicace acume critico lo portano a interessarsi di estetica, la nuova scienza che studia il concetto di arte e di bellezza. L'edizione nel 1808 del Trattato del Bello lo proietta in quel giro internazionale e cosmopolita di studiosi e artisti per i quali l'Europa è un'entità senza frontiere in cui si può discutere e scambiare le idee al di là dei gretti confini nazionalistici, secondo il pensiero più maturo dell'Illuminismo.
Francis Haskill che è il maggior interprete novecentesco del Cicognara traccia di lui un ritratto che mette in luce la poliedrica personalità del Cicognara: critico d'arte secondo la nuova accezione che si sta formando tra Sette e Ottocento, Cicognara è ancora un connoisseur, ovvero un dilettante di gusto, ma è stato anche mecenate e mercante d'arte, bibliofilo amministratore, politico, e, soprattutto, una delle menti europee più acute del suo tempo. Dalla erudizione alle strategie culturali, le scelte e le decisioni di Leopoldo Cicognara tracciano un percorso intellettuale non dimenticato e formativo della coscienza moderna.
Basti pensare alle istituzioni che ha creato, ancor oggi vitalissime in quella Venezia tragicamente splendida e grande nelle arti e nelle lettere tra il tramonto della Repubblica, la parentesi napoleonica e il ritorno all'Austria. Cicognara ha saputo sistemare la gloria di Venezia facendosi promotore di istituzioni grandiose come l'Accademia o l'Ateneo Veneto e nello stesso tempo creando il mito di Canova, dell'arte canoviana, ponendola al punto più alto di un percorso della scultura che ha nell'artista di Possagno l'artista più luminoso e irrepetibile.
 Sposato a Massimiliana Cislago, pupilla di Cesarotti e amica delle intelligenze più vive del suo tempo, da Foscolo al Giordani, da Madame de Staël a Joséphine Bonaparte, alla morte dell'amatissima moglie, nel 1808 si dedica esclusivamente alle attività culturali. Presidente della rinnovata Accademia di Venezia dal 1808 al 1826 e dell'Ateneo Veneto dal 1812, si dedica alla riorganizzazione dell'apparato museale veneziano e sovrintende alla carriera dei giovani artisti veneti, tra cui il grande Hayez, che sotto il controllo di Canova compiono il loro apprendistato a Roma.
Sposato a Massimiliana Cislago, pupilla di Cesarotti e amica delle intelligenze più vive del suo tempo, da Foscolo al Giordani, da Madame de Staël a Joséphine Bonaparte, alla morte dell'amatissima moglie, nel 1808 si dedica esclusivamente alle attività culturali. Presidente della rinnovata Accademia di Venezia dal 1808 al 1826 e dell'Ateneo Veneto dal 1812, si dedica alla riorganizzazione dell'apparato museale veneziano e sovrintende alla carriera dei giovani artisti veneti, tra cui il grande Hayez, che sotto il controllo di Canova compiono il loro apprendistato a Roma.
Rimarranno un modello di sensibilità civile i suoi interventi in difesa dell'urbanistica veneziana, come la sua strenua opposizione all'abbattimento della chiesa di San Geminiano per far posto al palazzo reale di Piazza San Marco voluto da Napoleone; o la difesa del progetto di Jappelli per la nuova Università di Padova; o l'organizzazione dell'omaggio delle province venete per il matrimonio di Francesco e Carolina d'Austria per la quale chiama i più raffinati artisti e artigiani veneti a decorare una stanza lussuosa per la Hofburg di Vienna tutta centrata sulla statua Polinnia del Canova.
La vera grande politica culturale del Cicognara si esercita, tuttavia, nelle grandi opere che lo rendono famoso in Europa: dalle Fabbriche di Venezia al Catalogo ragionato della sua splendida biblioteca che ora è uno dei vanti della Biblioteca vaticana e che rappresenta un insostituibile strumento di ricerca storico-artistica; ma soprattutto il valore e il senso dell'opera di Cicognara, intellettuale europeo, è affilata alla stesura di quella storia della scultura che lo occuperà praticamente per tutta la vita e che lo proietterà nell'olimpo dei grandi uomini di cultura del diciannovesimo secolo. Il titolo esatto dell'opera le il seguente: Storia della scultura dal suo Risorgimento in Italia sino al Secolo di Napoleone I per servire di continuazione alle opere di Winckelmann e di d'Agincourt.
Il primo volume esce nel 1813, il secondo nel 1816 e il terzo nel 1818. Ma per capire meglio il senso di un'operazione che si rivelerà assai compromessa con la politica e sicuramente non asettica, occorre ricordare che il secondo volume al posto del secolo di Napoleone porta la dicitura sino al secolo XIX; mentre il terzo, sostituisce la neutra indicazione, secolo XIX, con il ben più aderente secolo di Canova, quell'autore in cui egli ravvisava la gloria e la supremazia dell'arte della scultura su tutte le altre arti.
Il divino Canova, l'amico più caro e del quale diventerà l'illustratore e il critico più acuto, diventa il termine di paragone ineguagliato di tutta la storia dell'arte, ponendosi nella sua grandiosa visione dello sviluppo delle arti, al punto più alto e irraggiungibile.
Queste indicazioni rivelano la strategia dell'operazione: la dedica a Napoleone serve a finanziare l'impresa, come del resto quella a Francesco d'Austria, una volta cambiato il regime, quella a Canova la vera destinazione dell'opera. Ma non fu un'impresa fortunata: la lussuosità del formato, la quantità delle incisioni affidate ai migliori artisti del tempo, le spese di ricerca, nonostante le sovvenzioni francesi (e poco) austriache e le liste di associazione, portarono al definitivo dissesto delle finanze del Cicognara che dovette vendere, tramite Angelo Mai, la sua meravigliosa biblioteca alla Vaticana.
La strategia culturale di Cicognara si delinea così anche come un intervento politico di alta qualità e se oggi gli studi recenti tendono a limitare la sua attività come quella di un precursore del patriottismo liberale e risorgimentale, certo è che la sua libertà di pensiero in campo non solo politico, ma intellettuale e religioso sta a dimostrare come nella società d'antico regime vada rintracciata la spinta al grande movimento risorgimentale e come spesso proprio nei rappresentanti dell'aristocrazia fosse possibile ritrovare menti aperte e lucide come quelle del conte Leopoldo.
 Tra un'adesione alle tesi foscoliane, per inciso suo amico e amico di amici, Giordani o il nume del tempo, il divino Canova, nel giro europeo di amicizie importanti, la fedeltà a Giuseppina anche dopo il divorzio da Napoleone, la frequentazione assidua dell'aristocrazia europea più esclusiva, ma anche di quella nuova nata con l'Impero, il contatto assiduo con gli intellettuali più importanti del suo tempo, è difficile stabilire se Cicognara fosse una tête folle come lo ha chiamato Napoleone dopo lo scandalo Ceroni o un giacobino deluso o un massone; in realtà la figura di Leopoldo Cicognara va vista entro quella aristocrazia illuminata che, pur sconfessando da una parte l'ideologia più reazionaria dell'antico regime, sa operare in modo che l'effettiva carica rivoluzionaria di avanzatissime scelte culturali non rompa con il sistema politico in atto, ma lo usi per affermare una nuova e diversa progettualità.
Tra un'adesione alle tesi foscoliane, per inciso suo amico e amico di amici, Giordani o il nume del tempo, il divino Canova, nel giro europeo di amicizie importanti, la fedeltà a Giuseppina anche dopo il divorzio da Napoleone, la frequentazione assidua dell'aristocrazia europea più esclusiva, ma anche di quella nuova nata con l'Impero, il contatto assiduo con gli intellettuali più importanti del suo tempo, è difficile stabilire se Cicognara fosse una tête folle come lo ha chiamato Napoleone dopo lo scandalo Ceroni o un giacobino deluso o un massone; in realtà la figura di Leopoldo Cicognara va vista entro quella aristocrazia illuminata che, pur sconfessando da una parte l'ideologia più reazionaria dell'antico regime, sa operare in modo che l'effettiva carica rivoluzionaria di avanzatissime scelte culturali non rompa con il sistema politico in atto, ma lo usi per affermare una nuova e diversa progettualità.
Non è dunque cinismo quello che muove le scelte di Leopoldo; lo si è visto nella sua opposizione al regime napoleonico e nella resistenza al nuovo e più sospettoso regime austriaco, ma semmai quella fede assoluta nelle possibilità della bellezza espressione della civiltà di un popolo. La bellezza intesa come rigenerazione morale e sociale, come ben spiega Rosario Assunto nel parlare di Cicognara e che sottendeva una fondamentale libertà di pensiero tale da dover fare i conti con la censura, specie quella austriaca che vuole intervenire pesantemente in ciò che ravvisa come provocazioni libertarie che minacciavano l'assetto dell'equilibrio stato-religione.
Questa libertà di pensiero lo rende celebre in Europa ma non tanto quanto la sua amicizia con Canova. Un'amicizia che ci ha lasciato uno degli epistolari più interessanti dell'Ottocento e che copre con uno scambio di lettere quasi giornaliero il periodo che va dal 1810 al 1822, anno della morte di Canova. In questa testimonianza di una lunga fedeltà il lettore può imbattersi in uno spaccato di vita familiare vario e complesso: dal giudizio sulle opere del "divino", alla richiesta di perline, bulbi, oggetti minuti: dall'organizzazione dei pensionati veneti a Roma i commenti sugli avvenimenti capitali di quel tormentato momento politico: la campagna di Russia, il tramonto di Napoleone, ma anche il soggiorno a Malmaison presso Giuseppina, la più raffinata committente delle opere del Canova, per la quale, anche tramite Cicognara, Canova scolpirà le Grazie.
E si può immaginare un giro europeo come quello che si svolge tra Firenze e Parigi nel 1812, quando Foscolo e Giordani pensano di recarsi a Firenze per incontrale Luisa Stolberg contessa di Albany, colei che per amore di Alfieri fugge dal marito, ultimo Stuart, pretendente al trono d'Inghilterra e committente di Canova per il famoso monumento al Tragico in Santa Croce. A loro Cicognara scrive da Parigi per testimoniare l'impressione della statua canoviana del Paride, scolpita per Giuseppina e annunciando la prossima committenza delle Grazie.
Un giro internazionale di cui Cicognara è nello stesso tempo partecipe e critico e che gli serve per erigere all'amico il monumento della Storia della scultura, dove Canova è esaltato come il momento sommo dell'arte di ogni tempo. L'amicizia con i Napoleonidi, specie con Giuseppina e il figlio Eugenio non giovarono al Cicognara dopo la caduta dell'imperatore. Suddito veneziano, Leopoldo non può nemmeno frequentare i circoli ufficiali perché la seconda moglie, Lucia Fantinati, vedova di un Bentivoglio, non ha sufficienti titoli nobiliari per essere ricevuta in società. Le disavventure economiche lo colpiscono anche se il suo patrimonio ferrarese è gestito oculatamente dal cugino Girolamo Cicognara, podestà di Ferrara. Muore il 5 marzo 1834 a Venezia e i suoi funerali, nonostante la velata opposizione degli Austriaci, assumono un carattere di lutto cittadino: il corteo funebre sosta a quella Accademia da lui così fortemente sostenuta e lì vengono tenute le orazioni funebri.
A Ferrara dove ancora vivono i parenti Giglioli lascerà i manoscritti della Storia della scultura e le correzioni fatte dall'amico Pietro Giordani, ma soprattutto il suo busto colossale che Canova, l'amico da lui tanto amato gli regalò in cambio della divinizzazione della sua opera testimoniata nei suoi scritti. Il busto che fino a pochi anni fa si trovava nella Cella degli uomini illustri della Certosa di Ferrara ed ora è custodito nei Musei civici d'arte antica di Palazzo Schifanoia reca questa dedica, testimonianza fedele di un'amicizia intellettuale e umana che ha siglato il senso della storia dell'arte dell'Ottocento:
EFFIGIE DI LEOPOLDO CICOGNARA
OPERA ULTIMA DEL SUO AMICO ANTONIO CANOVA
POSTA QUI DAL COMUNE
A PERPETUO ONORE DELL'OTTIMO CITTADINO
CHE AMÒ L'ITALIA
E ILLUSTRÒ LA SUA PATRIA
MDCCCXXXIV.