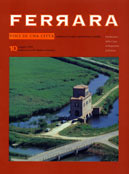La magnificentia della corte era tangibile nella ricchezza delle pitture, delle sculture, degli arredi che rivestivano camere private e sale di rappresentanza, ampi spazi o piccole stanze dei palazzi dei Duchi e dell'aristocrazia: decorazioni e affreschi facevano di quegli ambienti, stando a quanto descrive nel 1497 Sabadino degli Arienti, davvero «luoghi del cielo».
E' questo il "paradiso perduto" dell'arte ferrarese, spesso rievocato e ancor più spesso rimpianto: il patrimonio che costituiva il tessuto connettivo della città, a causa delle complesse vicende storiche di Ferrara, è stato smembrato, dando origine a quell'enorme «museo diffuso» cui accenna Gundersheimer nelle righe appena menzionate e di cui trattano inevitabilmente tutti i testi di storia artistica della città. A Parigi, a Londra, a New York, ma anche a Miami, Ottawa, Los Angeles o Sarasota: musei lontani e, talvolta, lontanissimi dall'Italia, conservano, tuttavia, testimonianze della civiltà figurativa di Ferrara. Basta localizzarli in un immaginario planisfero per rendere evidente la vastità del percorso compiuto dalle opere d'arte prodotte nella città estense.
 La mostra intitolata alla Leggenda del collezionismo tenutasi nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti tre anni fa, riproponeva all'attenzione del pubblico le tappe di quel lungo processo di dispersione che costituisce l'altra faccia del fenomeno del collezionismo. Fu un percorso che conobbe, insieme, brusche accelerazioni e momenti di stasi e dove si mescolarono indistricabilmente mercato e conoscenza critica, sensibilità artistica e avidità di guadagno. Sulla falsariga di quel che è emerso da quella esposizione e dalle suggestive pagine del saggio introduttivo di Andrea Emiliani sono nate una serie di iniziative di approfondimento della storia del collezionismo e, ancora di più, della dispersione.
La mostra intitolata alla Leggenda del collezionismo tenutasi nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti tre anni fa, riproponeva all'attenzione del pubblico le tappe di quel lungo processo di dispersione che costituisce l'altra faccia del fenomeno del collezionismo. Fu un percorso che conobbe, insieme, brusche accelerazioni e momenti di stasi e dove si mescolarono indistricabilmente mercato e conoscenza critica, sensibilità artistica e avidità di guadagno. Sulla falsariga di quel che è emerso da quella esposizione e dalle suggestive pagine del saggio introduttivo di Andrea Emiliani sono nate una serie di iniziative di approfondimento della storia del collezionismo e, ancora di più, della dispersione.
L'entità della dispersione del patrimonio ferrarese appare già evidente nella pura secchezza delle cifre scaturite da una recente indagine: ben novecento sono, infatti, le voci della schedatura anagrafica dei dipinti dispersi, basata sui cataloghi editi di collezioni pubbliche e private, frutto di una ricerca compiuta nel 1998 da Luca Majoli e Oriana Orsi con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara.
L'indagine, limitata ai soli dipinti, senza prendere ancora in considerazione l'enorme patrimonio di sculture e di arte applicata, è stata ripartita in tre settori : dipinti di sicura provenienza ferrarese, attualmente conservati in musei e collezioni italiane ed estere; dipinti che si trovano ancora a Ferrara, ma in una sede diversa da quella originaria; e, infine, opere di probabile, anche se non documentata, provenienza ferrarese.
Il censimento dei novecento dipinti finora rintracciati è un importante atto di recupero della memoria: i risultati dell'indagine, messi a disposizione del pubblico, potrebbero restituirci, magari nello spazio ristretto dello schermo di un computer, quella «scuola di Ferrara viva e parlante» che già Camillo Laderchi aveva visto dipanarsi sotto i suoi occhi negli oltre seicento dipinti che ornarono nel corso dell'Ottocento le pareti di palazzo Costabili in via Voltapaletto.
 Nel catalogo della mostra Il paradiso perduto. Per una archivio della memoria estense, aperta dal 15 aprile al 12 giugno 1999 nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti, abbiamo nuovamente ripercorso gli episodi fondamentali di quella sorta di "diaspora" che portò un imponente numero di opere a lasciare la città per emigrare nei musei e nelle collezioni di tutto il mondo. L'anno discriminante è il 1598, quando, finito il governo degli Estensi, la città passò allo Stato della Chiesa. Tutto comincia da un gesto di affermazione e di potere: il cardinale nipote Pietro Aldobrandini, delegato al governo della città, si impadronì subito dei grandi dipinti che ornavano il camerino privato del Duca Alfonso I e che per più di cinquant'anni erano stati offerti all'ammirazione della corte e degli ospiti illustri.
Nel catalogo della mostra Il paradiso perduto. Per una archivio della memoria estense, aperta dal 15 aprile al 12 giugno 1999 nella Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti, abbiamo nuovamente ripercorso gli episodi fondamentali di quella sorta di "diaspora" che portò un imponente numero di opere a lasciare la città per emigrare nei musei e nelle collezioni di tutto il mondo. L'anno discriminante è il 1598, quando, finito il governo degli Estensi, la città passò allo Stato della Chiesa. Tutto comincia da un gesto di affermazione e di potere: il cardinale nipote Pietro Aldobrandini, delegato al governo della città, si impadronì subito dei grandi dipinti che ornavano il camerino privato del Duca Alfonso I e che per più di cinquant'anni erano stati offerti all'ammirazione della corte e degli ospiti illustri.
Le prime opere a lasciare Ferrara furono, dunque, i Baccanali di Bellini, Tiziano e Dosso: le grandi tele di illusivo sensuale edonismo avevano segnato il punto più alto di quella "cresta sottile", momento perfetto di armonia e pienezza che definisce per Burckhardt il Rinascimento italiano.
Pietro Aldobrandini, lo stesso che aveva trattato con Lucrezia d'Este le condizioni della devoluzione del Ducato estense, fu il primo ad avere diritto di scelta fra i principi della Chiesa che, come Scipione Borghese, avevano seguito il Pontefice nell'impresa ferrarese non soltanto per avidità di gloria, ma anche perché «ebbri dal desiderio di possedere pitture».
Annibale Roncaglia, agente del duca Cesare, è, invece, il primo a vedere completamente spoglio il Camerino, luogo simbolo delle raffinatezze della vita cortese: i dipinti tolti dalla loro sede finirono per restare dapprima quasi colpevolmente occultati nella dimora romana degli Aldobrandini, per poi traslocare - per pressanti motivi economici - nei più ricchi palazzi reali di Spagna e, più tardi, negli altrettanto lussuosi musei americani e inglesi. Questa fu la sorte degli arredi profani che Cesare d'Este non riuscì a trasferire nella nuova sede ducale di Modena.
 Il silenzio dei due successivi secoli del dominio pontificio è rotto soltanto da documenti da cui si intravede, comunque, un'intensa attività collezionistica che coinvolge non soltanto i Cardinali Legati, ma anche l'aristocrazia cittadina: caso esemplare è la raccolta Canonici. La collezione, che, stando alle parole di Marc'Antonio Guarini, poteva «stare a paragone di [quella di] qualsivoglia principe» era stata formata da Roberto Canonici, cultore delle arti e destinatario, nel 1621, di una impegnativa dedica nell'Apparato degli huomini illustri di Antonio Superbi. La raccolta fu distrutta nel 1639 da un incendio apparentemente devastante, ma certo bene accolto dagli eredi che potevano eludere così le pesanti condizioni testamentarie che vietavano la vendita o lo smembramento della raccolta.
Il silenzio dei due successivi secoli del dominio pontificio è rotto soltanto da documenti da cui si intravede, comunque, un'intensa attività collezionistica che coinvolge non soltanto i Cardinali Legati, ma anche l'aristocrazia cittadina: caso esemplare è la raccolta Canonici. La collezione, che, stando alle parole di Marc'Antonio Guarini, poteva «stare a paragone di [quella di] qualsivoglia principe» era stata formata da Roberto Canonici, cultore delle arti e destinatario, nel 1621, di una impegnativa dedica nell'Apparato degli huomini illustri di Antonio Superbi. La raccolta fu distrutta nel 1639 da un incendio apparentemente devastante, ma certo bene accolto dagli eredi che potevano eludere così le pesanti condizioni testamentarie che vietavano la vendita o lo smembramento della raccolta.
Ma il mercato dell'arte è pur sempre ancora limitato all'interno di Ferrara. Solo col regime napoleonico un vero e proprio terremoto sconvolse la silenziosa e addormentata quiete della città, tante volte evocata dai viaggiatori stranieri.
Nel 1796, Quatremère de Quincy lamenta già di veder «andare a morire in terre straniere» capolavori dell'arte italiana che gli apparivano «mutilati e lacerati, abbandonati all'incuria e ben presto all'oblio». Parole valide certamente anche per Ferrara: la soppressione di ordini e corporazioni religiose portava con sé, come altrove, l'inevitabile corollario delle requisizioni di opere d'arte destinate ad alimentare la neonata Pinacoteca di Brera fortemente voluta dall'ambizione del viceré d'Italia, Eugenio Beauharnais, a imitazione del parigino Musée Napoléon.
Ancora opere d'arte, provenienti da chiese e conventi soppressi, furono vendute nelle aste organizzate per rimpinguare velocemente le casse della nuova amministrazione napoleonica. Gli acquirenti, spesso, erano esponenti del nuovo ceto borghese ferrarese recentemente elevatosi a fasti nobiliari, che univa autentiche preoccupazioni civiche al desiderio di confermare lo status sociale appena raggiunto.
 Nel 1817, in un periodo di apparente "ritorno ALL'ordine" all'indomani della Restaurazione, Leopoldo Cicognara deplora la partenza di «...convogli di quadri preziosi a centinaia acquistati per vilissimi prezzi nelle primarie famiglie alla rinfusa...»; dal punto di vista del mercato dell'arte era, dunque, definitivamente finito quel vasto silenzio che aveva impalpabilmente avvolto la città per quasi due secoli. Inizia, invece, il tempo fervido del grande collezionismo ottocentesco: i conoscitori e gli esperti d'arte confluiscono in Ferrara da tutta Europa acquistando opere per i nuovi musei di mezzo mondo e spartendosi quel che restava della grande tradizione figurativa della città. Nella stessa Ferrara si formano quelle quadrerie private di cinquecento o seicento pezzi che sono state protagoniste dell'esposizione La leggenda del collezionismo, tre anni or sono.
Nel 1817, in un periodo di apparente "ritorno ALL'ordine" all'indomani della Restaurazione, Leopoldo Cicognara deplora la partenza di «...convogli di quadri preziosi a centinaia acquistati per vilissimi prezzi nelle primarie famiglie alla rinfusa...»; dal punto di vista del mercato dell'arte era, dunque, definitivamente finito quel vasto silenzio che aveva impalpabilmente avvolto la città per quasi due secoli. Inizia, invece, il tempo fervido del grande collezionismo ottocentesco: i conoscitori e gli esperti d'arte confluiscono in Ferrara da tutta Europa acquistando opere per i nuovi musei di mezzo mondo e spartendosi quel che restava della grande tradizione figurativa della città. Nella stessa Ferrara si formano quelle quadrerie private di cinquecento o seicento pezzi che sono state protagoniste dell'esposizione La leggenda del collezionismo, tre anni or sono.
La creazione nel 1836 della Pinacoteca cittadina per opera della parte più illuminata della cittadinanza tentò di contrastare la dispersione, l'alienazione o la vendita di queste raccolte, secondo un progetto di grande valore civico, ma ormai inutile a impedire la grande " diaspora" già IN parte avvenuta. Se conoscere equivale a possedere, l'attuale ricerca sui dipinti dispersi, ritrovati e schedati, aiuta a riprendere possesso, colmandone le lacune, del tessuto culturale ferrarese.
Accanto a questa opera di ricostruzione teorica e di indagine, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara sta attuando, insieme alla Pinacoteca Nazionale, un complesso progetto di ricomposizione del volto storico della città, riacquistando opere sottratte nel corso del tempo alla loro originaria collocazione.
Come per il restauro di un mosaico, dove è necessario, contemporaneamente, conoscere l'intero disegno e poi pazientemente recuperare e rimettere a posto ogni singola tessera mancante, così ogni dipinto che ritorna a Ferrara riempie un vuoto, reintegra una singola lacuna, ma consente anche di cogliere al meglio la completezza della raffigurazione.
 Il sottile filo rosso della memoria storica della città lega, dunque, le opere in mostra, tutte ritornate definitivamente a Ferrara dopo lunghi tragitti. Il merito della Fondazione consiste non solo nell'acquisto, ma anche nei preliminari della ricerca svolta nelle aste, nelle dimore dei collezionisti o nelle botteghe antiquarie italiane o straniere, per recuperare quanto più è possibile dell'originario patrimonio figurativo ferrarese.
Il sottile filo rosso della memoria storica della città lega, dunque, le opere in mostra, tutte ritornate definitivamente a Ferrara dopo lunghi tragitti. Il merito della Fondazione consiste non solo nell'acquisto, ma anche nei preliminari della ricerca svolta nelle aste, nelle dimore dei collezionisti o nelle botteghe antiquarie italiane o straniere, per recuperare quanto più è possibile dell'originario patrimonio figurativo ferrarese.
Così sono rientrate in città opere di provenienze diverse. Sono ritornati i due ultimi pezzi rimasti sul mercato della collezione Sacrati Strozzi, emigrata da tempo a Firenze: le due belle Madonne con Bambino di Giovanni da Modena e Biagio d'Antonio, certo non dovevano sfigurare nella straordinaria raccolta di cui il ferrarese marchese Massimiliano aveva voluto adornare le pareti del proprio palazzo di famiglia, in piazza san Domenico.
Da un'asta Sotheby's proviene la grande Crocifissione con i SS. Pietro, Andrea e il committente Bernardino Barbuleio, nata per la chiesa di San Pietro, ma successivamente passata nell'altra grande collezione della Ferrara ottocentesca: quella di Giovan Battista Costabili.
Erano finiti sul mercato inglese, tradizionalmente interessato alla cultura ferrarese, due suggestivi Paesaggi con figure di Scarsellino, i cui soggetti non sono stati ancora identificati, Non sappiamo chi siano né i misterioso fanciullo nero né il cavaliere abbigliato di rosso con copricapo piumato che appaiono in tutti i dipinti della serie, forse legata a qualche tema elaborato dalla intellettuale e raffinata cultura di corte. Pienamente ferrarese è il paesaggio che si apre sullo sfondo della Sacra Famiglia con San Giovannino attribuita a Bononi e finita, per chissà quali vicende collezionistiche, in una raccolta romana.
I due bozzetti (o più probabilmente repliche in piccolo) di Giuseppe Maria e Luigi Crespi delle due grandi pale della chiesa del Gesù con il Miracolo di San Francesco Saverio e l'Estasi di San Stanislao Kostka documentano la ricchezza decorativa dell'ancora misconosciuta Ferrara settecentesca. Proviene da collezioni estensi, e adornava chissà quale aristocratica cappella, la tavola di Niccolò Pisano con la Adorazione dei Magi, l'ultimo dipinto, in ordine di tempo, a essere stato acquistato. Si compie così un'altra tappa nel lungo percorso di riappropriazione da parte della città del proprio glorioso passato, di quel paradiso perduto che dalla memoria dei ferraresi non è mai scomparso del tutto.
Francesco Leopoldo Cicognara nasce a Ferrara nel 1767 dal conte Filippo e da Luigia Gaddi forlivese. La sua è un'antica e illustre famiglia radicata a Ferrara già nel XV secolo, ma di ancor più lontana radice cremonese. Nella Ferrara legatizia, ormai lontana dai fasti estensi, la classica educazione del primogenito delle grandi famiglie è affidata al Collegio dei Nobili di Modena dove il giovane contino non brillò per particolari meriti culturali, ma come nota il rettore dell'Istituto, per l'inclinazione al ballo e alla pittura: «aveva talento, ma non ha voluto studiare».
Una indocilità dunque di temperamento che lo spinge a rivolgere le proprie curiosità intellettuali alla poesia, ma soprattutto alla pittura che non è certo una scelta consueta per i rappresentanti della classe nobiliare: una scelta immediatamente osteggiata dal padre. Fare il pittore di professione è una decisione singolare in una società d'antico regime, in una ex capitale come Ferrara scaduta al rango di appendice del dominio pontificio, in un luogo cioè che non sa sostituire il vagheggiamento di uno splendido passato con l'entusiasmo per l'incendio provocato dai "lumi", anche se qualche tenue bagliore arriva a rischiararne le nebbie.
Sarebbe stato più facile per esempio dedicarsi alla poesia, sull'esempio trasgressivo di Vittorio Alfieri; le lettere, si sa, hanno nella scala dei valori dell'antico regime una patente di nobiltà che non spetta alle arti visive e l'esempio dei conti Alfieri, Leopardi, Manzoni ne è una splendida riprova. Di questa inclinazione e scelta un intellettuale di gran peso come Niccolò Tommaseo tracciò un giudizio sprezzante; per lui Leopoldo Cicognara fece mediocri paesaggi, scrisse dei versi sulle ore, che passarono con esse.
E certo la fama del conte ferrarese non è affidata né ai corretti dipinti, di cui restano tracce nel paesaggio Treves, né tantomeno a poemetti come Il mattino, il mezzogiorno, la sera, e la notte o Le belle arti che rappresentano il frutto più maturo della sua attività poetica , tra il 1789 e il 1790, e che vanno visti semmai dentro una visione illuminista particolarmente attenta a ciò che accadeva nei centri più vivaci della cultura italiana: la pariniana Lombardia asburgica o la Napoli pre rivoluzionaria, vivace fucina di scelte filosofiche o ideologiche all'avanguardia.