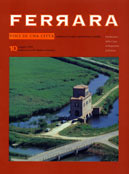Dei tre elementi il primo, nella sequenza delle date, è il campanile. Sappiamo che l'autore, come è accreditata convinzione degli storici, è Leon Battista Alberti. Un Alberti arcaico (2) che disegna il suo "monumento romano" con gli archi abbinati dal risentito chiaroscuro, non dimenticando però, o forse volendo esplicitamente ricordare, i modi romanici che segnano in modo così autonomo l'esterno del Duomo a cui il campanile deve accostarsi.
Dei tre elementi il primo, nella sequenza delle date, è il campanile. Sappiamo che l'autore, come è accreditata convinzione degli storici, è Leon Battista Alberti. Un Alberti arcaico (2) che disegna il suo "monumento romano" con gli archi abbinati dal risentito chiaroscuro, non dimenticando però, o forse volendo esplicitamente ricordare, i modi romanici che segnano in modo così autonomo l'esterno del Duomo a cui il campanile deve accostarsi.
Forse coglie queste suggestioni in Francia; forse è una scelta precisa e autonoma fatta di ricordi: certo è che lo stretto giro degli archi che disegnano le quattro fronti del fusto e l'alternanza delle fasce bianchi e rosate, che sembrano richiamare a una volontà di visione orizzontale in contrasto con la forza verticale delle pilastrate d'angolo, conferiscono a questa grande scultura il segno preciso delle sue ascendenze romaniche (3).
Ascendenze riconoscibili nella grande parete dell'abside con la sua reiterata curvatura. Se pensiamo agli avvii delle opere, passano circa settant'anni fra le due architetture. Sono anni fecondi nell'elaborazione di quel momento magico che definiamo Rinascimento (definizione con molti limiti) e che consentono a Biagio Rossetti, che disegna l'architettura dell'abside, di liberarsi delle sue radici medioevali o tardo gotiche e di impadronirsi di quella nuova cultura, di filtrarla, di commentarla con i modi e i materiali locali (il cotto dei paramenti come "paesaggio" della città) e farla diventare autentico e autonomo linguaggio, fino a esiti, anche urbanistici, straordinari.
 Due percorsi del Rinascimento, dunque, sono inverati e leggibili in due architetture accostate, due percorsi che hanno origine nel medesimo crogiuolo della cultura medioevale: forse nel medioevo francese o in quello germanico, il primo (si pensi alla facciata del Duomo); e nel medioevo della tarda cultura gotica locale, il secondo.
Due percorsi del Rinascimento, dunque, sono inverati e leggibili in due architetture accostate, due percorsi che hanno origine nel medesimo crogiuolo della cultura medioevale: forse nel medioevo francese o in quello germanico, il primo (si pensi alla facciata del Duomo); e nel medioevo della tarda cultura gotica locale, il secondo.
Essi costituiscono, comunque, due testi fondamentali di architettura: perciò, avere la possibilità, come abbiamo, di vederli accostati e sovrapposti, comunque contigui e contemporaneamente leggibili, è un avvenimento che provoca sollecitazioni affascinanti.
Ma abbiamo detto che tre sono le opere che conducono a quella sintesi a cui abbiamo fatto cenno: la terza è il grande catino dipinto che la curva dell'abside ingloba in alto, all'interno del coro della Cattedrale: l'opera-principe di un maestro ferrarese, Sebastiano Filippi detto il Bastianino. Esterno e interno; architettura e pittura: è la realtà del volume dell'abside, non solo bellissima parete esterna, ma contenitore di preziosa materia dipinta.
«Sebastiano Filippi,» ha scritto Francesco Arcangeli, «è un personaggio unico, non dirò in Ferrara, ma nella pittura italiana del tempo» e, più avanti, dopo aver apparentato il suo gusto velato allo "sfumato" di Leonardo, continua: «Le nebbie dei suoi dipinti hanno un senso profondo, storico. Lo si potrà dire meglio o peggio non importa, ma non si può tradire l'importanza di un artista che fu fra i protagonisti del 'tramonto del Rinascimento' in uno dei centri che del Rinascimento erano stati la voce viva» (4).
 Il Bastianino dipinge il catino del coro a partire dal 1577: date significative nella sequenza che stiamo descrivendo. Ancora poco più di settant'anni dividono il suo affresco dall'architettura che lo contiene, circa quanti erano, lo abbiamo detto, quelli che dividevano la grande "scultura" del campanile albertiano dalla nuova abside di Rossetti. È una scansione evidentemente solo singolare che raggruppa, però, in modo emblematico tre avvenimenti di tanta rilevanza artistica.
Il Bastianino dipinge il catino del coro a partire dal 1577: date significative nella sequenza che stiamo descrivendo. Ancora poco più di settant'anni dividono il suo affresco dall'architettura che lo contiene, circa quanti erano, lo abbiamo detto, quelli che dividevano la grande "scultura" del campanile albertiano dalla nuova abside di Rossetti. È una scansione evidentemente solo singolare che raggruppa, però, in modo emblematico tre avvenimenti di tanta rilevanza artistica.
Si va dal medioevo delle architetture nella loro ascendenza, alla loro realtà rinascimentale, fino alla conclusione del Rinascimento, quando gli ultimi fuochi del magistero michelangiolesco si spengono nell'alta e malinconica dissoluzione del segno di Bastianino.
Pensare realtà tanto importanti consegnate e viventi in così poco spazio non è, da noi, avvenimento fuori dalle regole: quello che ritengo significativo è che esse segnano, in un certo senso, un inizio e una fine: la traiettoria rinascimentale sembra avere proprio qui punti rilevanti della sua straordinaria realtà.
Tutto questo, in anni lontani, ha rischiato di andare perduto, così come di schianto è andata perduta la chiesa di San Benedetto.
Grappoli di bombe alleate sono caduti, prima, sulle mura di San Paolo, facendo strage in un rifugio (ottanta morti); poi, nelle aree interstiziali del Duomo e del suo campanile: bombe che avrebbero potuto distruggere completamente le tre realtà rinascimentali delle quali abbiamo appena parlato (anche se i cittadini morti furono dodici (5)).
 Era il 1944 e, da allora, questi luoghi, fortunosamente scampati alle distruzioni, hanno risuonato solo di sussurri e grida, fino al 1998, quando la loro memoria è uscita dall'oblio a cui sembrava condannata.
Era il 1944 e, da allora, questi luoghi, fortunosamente scampati alle distruzioni, hanno risuonato solo di sussurri e grida, fino al 1998, quando la loro memoria è uscita dall'oblio a cui sembrava condannata.
Visitando questo luogo da turista, ma forse anche da ferrarese - ignaro, se è giovane, della sarabanda di ferro e di fuoco scatenata sulla città in quegli anni - viene da chiedersi quali possano essere state le ragioni di tanta colpevole (e apparente) incuria.
Scrive Mare Augé in un suo testo sulla città fra immaginario e finzione: «Memoria e storia si coniugano nella città. Ciascuno degli abitanti della città ha un suo rapporto personale con i monumenti che, a loro volta, sono i testimoni di una storia più profonda e più collettiva.
In questo senso il percorso urbano ogni individuo è un modo di appropriarsi della attraverso la città. Beninteso, questo riferimento alla storia non è decifrato con esattezza da ciascuno di coloro che effettuano il percorso, ma impegna tutti gli spostamenti, in particolare quando si incrociano gli itinerari degli abitanti della città e dei suoi visitatori, turisti di un giorno, che ricordano ai primi che il loro 'quadro di vita' può essere per altri un oggetto di curiosità e di ammirazione» (6).
Certo: curiosità e ammirazione. Curiosità, se il luogo visitato è quello che abbiamo descritto, per lo stato di abbandono in cui attualmente versa; ammirazione, per quanto il visitatore attento e sensibile riesce a cogliere delle concrete presenze in quel luogo. Il "quadro di vita" dei cittadini di Ferrara rispetto al problema dei bombardamenti sulla città e alle loro oltre mille vittime, è quello della totale rimozione, che coinvolge non solo i giovani, ma anche gli anziani che hanno vissuto dentro o vicino alla tragedia: totale e voluta ignoranza dei drammi che hanno sconvolto metà delle famiglie ferraresi in quegli anni e distrutto, oltre a monumenti e cose, quasi il cinquanta per cento del patrimonio edilizio che strutturava la città.
 Latenze memoriali di questi fatti sembrano comparire appena, in questi giorni, quando sentiamo l'audio della televisione che ci rimanda l'ululato degli allarmi aerei su Belgrado.
Latenze memoriali di questi fatti sembrano comparire appena, in questi giorni, quando sentiamo l'audio della televisione che ci rimanda l'ululato degli allarmi aerei su Belgrado.
Anche la chiesa di San Benedetto, totalmente distrutta, è vissuta da tutti come un edificio "antico", senza che mai ci si ponga il problema della sua ricostruzione come era e dove era: per cui, oggi, caduta l'aura della storia, dovremmo correttamente percepirla e viverla come un grande modello al vero della chiesa edificata da Biagio Rossetti.
Bisogna dire che, per i luoghi della Cattedrale, ha contribuito a questa rimozione del problema dal quadro di vita dei ferraresi, direi in modo determinante, la lunga e defatigante vicenda amministrativa e burocratica che ha impedito, con cavilli continuamente reiterati, che fosse fatta chiarezza su come doveva essere realizzato il progetto di risarcimento dei luoghi.
Tutta questa sofferenza che ha immobilizzato ogni volontà è stata documentata nel Libro Bianco (7) un "diario" annotato quasi giorno per giorno con quello che accadeva a Roma e a Ferrara sul problema: Libro Bianco che è stato determinante per arrivare finalmente alla soluzione.
In quelle pagine, che coprono un arco di oltre mezzo secolo, si legge in filigrana tutta la storia e l'evoluzione della cultura del restauro: da quando il 'verbo' era Gustavo Giovannoni, con la sua teoria del "diradamento" alla quale si affiancava quella dell'"isolamento dei monumenti", fino a quella che sosteneva la ricostruzione del monumento distrutto come era e dove era.
 La conclusione che il Libro Bianco e le polemiche della stampa hanno determinato, è stata sancita il 30 ottobre 1998 (e amministrativamente autorizzata il 25 marzo 1999), quando gli esperti del Ministero dei Beni Culturali hanno affermato, approvando un ultimo e definitivo progetto, la teoria del "documento che diventa monumento" che stabilisce come sia fondamentale la conservazione di ogni testimonianza e di ogni trauma subiti dal monumento e che in qualche modo ne abbiano modificato l'assetto: niente delle vicende che hanno segnato il monumento e niente della sua storia deve andare perduto. Il monumento - sia esso una pittura, un'architettura, un ambiente - deve accogliere e rendere visibile, come in un palinsesto della propria storia, i documenti della vicenda secolare (8).
La conclusione che il Libro Bianco e le polemiche della stampa hanno determinato, è stata sancita il 30 ottobre 1998 (e amministrativamente autorizzata il 25 marzo 1999), quando gli esperti del Ministero dei Beni Culturali hanno affermato, approvando un ultimo e definitivo progetto, la teoria del "documento che diventa monumento" che stabilisce come sia fondamentale la conservazione di ogni testimonianza e di ogni trauma subiti dal monumento e che in qualche modo ne abbiano modificato l'assetto: niente delle vicende che hanno segnato il monumento e niente della sua storia deve andare perduto. Il monumento - sia esso una pittura, un'architettura, un ambiente - deve accogliere e rendere visibile, come in un palinsesto della propria storia, i documenti della vicenda secolare (8).
In questo complesso di problemi di riordino complessivo che attiene particolarmente alle architetture e all'ambiente, il grande catino affrescato dal Bastianino evidentemente non entra. Anche il finanziamento dell'intervento di restauro pittorico si deve alla liberalità della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ferrara.
Ma una fortunata coincidenza di date consente l'inizio di questo restauro insieme a quello della architettura dell'abside e della sagrestia settecentesca, deciso e finanziato invece dal Ministero.
E, ancora, tutto questo avviene in concomitanza con la risistemazione della aree che contornano l'abside il cui argomento centrale è quello relativo alla costruzione della nuova sagrestia della Cattedrale, struttura fondamentale di questa area sacra di cui la Cattedrale è stata privata per più di mezzo secolo, dopo i bombardamenti che hanno distrutto il coretto settecentesco che aveva, a sua volta, sostituito la ancora più antica Sagrestia Nova edificata dal vescovo Giovanni da Tossignano.
 Dunque, anche se per percorsi burocratici e amministrativi differenti e con diverse motivazioni, il cantiere che sta per aprirsi dentro e fuori l'abside del Duomo e nei suoi dintorni, si configura come un grande cantiere di restauro destinato a portare a compimento, negli anni immediatamente futuri, un grande disegno che la città e gli studiosi attendono ormai da troppi anni.
Dunque, anche se per percorsi burocratici e amministrativi differenti e con diverse motivazioni, il cantiere che sta per aprirsi dentro e fuori l'abside del Duomo e nei suoi dintorni, si configura come un grande cantiere di restauro destinato a portare a compimento, negli anni immediatamente futuri, un grande disegno che la città e gli studiosi attendono ormai da troppi anni.
La nuova sagrestia, con i relativi servizi, il cui volume si affaccerà su via Guglielmo degli Adelardi insieme al Lapidario, sarà la costruzione "nuova" che entrerà nel complesso dei lavori i quali prevedono anche una pavimentazione che copra le aree che fasciano l'Abside, pavimentazione che arriva fino al luogo dove la bombe sono cadute, cioè nell'attuale "vuoto" che si affaccia verso la piazza Trento Trieste.
Qui, lapidi terragne porteranno incisi i nomi di tutti i morti, a Ferrara, a causa delle bombe, per fissarne la memoria nell'immaginario della città in un luogo emblematico.
La Madonna quattrocentesca di Antonio da Firenze, che subì la violenza delle bombe e i cui frantumi furono raccolti e amorevolmente ricomposti (9), vigilerà su questa "area della memoria" affacciata sulla piazza e protetta da una lunga cancellata.
Del campanile saranno messe in luce le strutture basamentali già in parte ritrovate e ora coperte dall'ampio marciapiedi. La larga gradonata che emergerà da questi scavi darà finalmente il giusto risalto alle quattro figure scolpite negli angoli del Campanile, simboleggianti gli Evangelisti, opera di un lapicida di cultura gotica, e ci consentirà di ritrovare l'antica quota della piazza detta allora di San Crispino.
Un grande cantiere, dunque, per tre grandiosi restauri che forniranno al quadro di vita dei cittadini di Ferrara nuovi stimoli alla memoria e al ricordo; ai visitatori, un motivo ulteriore di ammirazione e di apertura all'immaginario; e alla cultura della città, finalmente, un risarcimento coerente con la dimensione poetica e lo spessore storico del luogo dopo i lunghi anni di sofferenza e di abbandono.
Note
1. Ch. Norberg Schulz, Esistenza Spazio Architettura, Roma, Officina Edizioni, 1994.
2. Mario Salmi, "Il Campanile della Cattedrale di Ferrara", Commentarii n.2, Aprile-giugno 1962.
3. Mario Salmi, op.cit.
4. Francesco Arcangeli, Il Bastianino, Ferrara, Cassa di Risparmio di Ferrara, 1963-
5. Giorgio Gandini, Ferrara sotto le bombe, in corso di pubblicazione.
6. Mare Auge, Disneyland e altri non-luoghi, Milano, Bollati Boringhieri, 1999.
7. Diocesi di Ferrara Comacchio, Capitolo Cattedrale, Libro Bianco 1945-1998, a cura di Chiara Montanari, Ferrara, Corbo editore, 1998.
8. Dice Françoise Choay in L'orizzonte del posturbano, a cura di S. Ernesto d'Alfonso, Roma, Officina Edizioni, 1992: «Gli unici monumenti che noi oggi possiamo permetterci e che noi possiamo accettare sono quelli che non si rivolgono più a una comunità limitata, ma alla umanità intera come i luoghi dove sorsero i campi di concentramento nazisti dove l'incommensurabilità del crimine domandava una memoria forte contro l'oblio. E la memoria è consacrata nella stessa realtà, come 'fermata' priva di uso: il loro simbolismo è nella ostentazione semplice e drammatica della loro realtà, è il documento-che-diventa-monumento.»
9. Al recupero di questa importante scultura in cotto, ora esposta al Museo di Schifanoia, hanno dedicato le loro cure Gualtiero Medri che raccolse personalmente i frantumi di essa e, successivamente, provvidero al restauro Ranieri Varese e Anna Maria Visser.