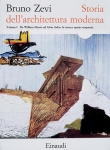 Ho deciso, allora, di dedicarmi a tre momenti, rilevanti - e non solo per me - del suo itinerario di maestro, tentando, attraverso l'affiorare del senso complessivo del suo operare, di coglierne la forza morale straordinaria e - credo - l'inimitabile e inimitata capacità di essere al centro del dibattito contemporaneo sulle arti e sull'architettura in particolare.
Ho deciso, allora, di dedicarmi a tre momenti, rilevanti - e non solo per me - del suo itinerario di maestro, tentando, attraverso l'affiorare del senso complessivo del suo operare, di coglierne la forza morale straordinaria e - credo - l'inimitabile e inimitata capacità di essere al centro del dibattito contemporaneo sulle arti e sull'architettura in particolare.
Primo momento. Semidistrutto, ma fra i libri a me più cari, vive ancora nella mia biblioteca Verso un'architettura organica, del 1945, il primo testo, il manifesto, con cui Bruno Zevi ha iniziato il suo magistero. Tre anni dopo usciva, sempre da Einaudi, Saper vedere l'architettura. Per la storia dell'architettura italiana questi furono due momenti particolarmente importanti. Ebbi il privilegio di leggere questi avvenimenti choc da un punto di vista particolare: la Facoltà di architettura di Milano presso la quale studiavo e che era, in quegli anni straordinari, la roccaforte del verbo razionalista, cioè di quel movimento di pensiero e di produzione dell'architettura che si rifaceva ai grandi nomi di Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe.
Ebbi il privilegio di leggere questi avvenimenti choc da un punto di vista particolare: la Facoltà di architettura di Milano presso la quale studiavo e che era, in quegli anni straordinari, la roccaforte del verbo razionalista, cioè di quel movimento di pensiero e di produzione dell'architettura che si rifaceva ai grandi nomi di Le Corbusier, Walter Gropius, Mies van der Rohe.
Movimento rigoroso con accenti quasi calvinisti nella sua etica progettuale secondo cui la forma doveva interpretare la funzione con assoluta trasparenza ("L'ornamento è delitto", diceva e scriveva Adolf Loos).
Erano, certamente, quelle di Zevi, nei due testi citati, posizioni polemiche molto vivaci rispetto a quelle regole e il nuovo verbo organico fu accolto e commentato con molte riserve e contestazioni.
"La moderna istanza sociale si transita concretamente in architettura proprio nella inventività spaziale, nel portare l'attenzione sui contenuti, anziché sul contenente e nel plasmare l'edificio in nome della fruizione umana". Ma il fatto importante che andava determinandosi in questi testi, fatto determinante, era la presa di coscienza, che diventava struttura di pensiero, del concetto di spazio che informerà, da allora, tutto l'operare culturalmente più sensibile degli architetti italiani. Lo straordinario di queste polemiche che determinarono la formazione di associazioni contrapposte (APAO a Roma; MSA a Milano) e di RELATIVE riviste ("Metron" a Roma e "Casabella", ormai antica insegna, a Milano) è stata, dopo una corretta e storicizzata lettura delle architetture realizzate, la scoperta di una inconscia affinità nella ricerca da parte dei maggiori protagonisti del razionalismo italiano.
Ma il fatto importante che andava determinandosi in questi testi, fatto determinante, era la presa di coscienza, che diventava struttura di pensiero, del concetto di spazio che informerà, da allora, tutto l'operare culturalmente più sensibile degli architetti italiani. Lo straordinario di queste polemiche che determinarono la formazione di associazioni contrapposte (APAO a Roma; MSA a Milano) e di RELATIVE riviste ("Metron" a Roma e "Casabella", ormai antica insegna, a Milano) è stata, dopo una corretta e storicizzata lettura delle architetture realizzate, la scoperta di una inconscia affinità nella ricerca da parte dei maggiori protagonisti del razionalismo italiano.
Giuseppe Terragni - il maestro di tutti i milanesi - nelle sue architetture e segnatamente nella Casa del Fascio di Como e nell'asilo Sant'Elia, approda a una concezione dello spazio che è propriamente lo spazio dell'architettura organica, cioè dello spazio matrice della forma, e direi approda a un'alta e insuperata poetica.
 Zevi, cioè, aveva avuto la straordinaria intuizione di dare senso vero ALL'operare degli architetti, anche forzando quei distretti culturali che parevano dover essere impermeabili a ogni messa in discussione del proprio pensiero.
Zevi, cioè, aveva avuto la straordinaria intuizione di dare senso vero ALL'operare degli architetti, anche forzando quei distretti culturali che parevano dover essere impermeabili a ogni messa in discussione del proprio pensiero.
Oggi, chi parla più di architettura organica o di architettura razionalista?
Fondamentale resta la poetica dello spazio. E l'aver messo in primo piano questa esigenza e questa struttura di pensiero nella ricerca architettonica fu certamente, nel nostro paese, merito esclusivo di Bruno Zevi. Era questo il suo destino: il suo alto destino di visionario.
Secondo momento. Nella sterminata quantità dei suoi interventi, mi pare importante, in questa lettura personale della presenza di Zevi e del suo lungo magistero, soffermarmi su un testo poco noto che, a mio avviso, riassume in modo direi fondante, data la sua natura, tutta la struttura di pensiero che regge la sua opera di critica e di interpretazione dei valori dell'architettura come missione profetica.
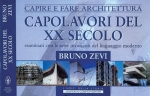 Mi riferisco al discorso Ebraismo e concezione spazio-temporale dell'arte con il quale, nel 1974, Bruno Zevi apriva il IX Congresso delle Comunità Israelitiche Italiane, a Roma, in Campidoglio. L'assunto era condurre un sondaggio per capire come l'architettura possa trovare nell'ebraismo quei valori e quei significati che esorbitano dall'ambito proprio del popolo ebraico, ma dall'ebraismo traggono il loro senso più vero: "...No alla immagine immobile, statica, classica, proporzionata e naturalistica; sì al racconto storico, espressionista, dinamico".
Mi riferisco al discorso Ebraismo e concezione spazio-temporale dell'arte con il quale, nel 1974, Bruno Zevi apriva il IX Congresso delle Comunità Israelitiche Italiane, a Roma, in Campidoglio. L'assunto era condurre un sondaggio per capire come l'architettura possa trovare nell'ebraismo quei valori e quei significati che esorbitano dall'ambito proprio del popolo ebraico, ma dall'ebraismo traggono il loro senso più vero: "...No alla immagine immobile, statica, classica, proporzionata e naturalistica; sì al racconto storico, espressionista, dinamico".
Zevi arriva a questa identificazione dei valori autentici dell'architettura attraverso una lettura attenta e affascinante dell'atto divino che ha fondato il mondo: atto che non è tale perché in realtà è un processo nel tempo (i sei giorni per creare il mondo).
 Questo processo avrebbe potuto determinare "un mondo perfetto, nitido, incorrotto e incorruttibile" dove l'uomo era "condannato ALL'estasi". Dio non volle questo, "ha dipinto un quadro a metà... lasciando al fruitore il compito di integrare la sua opera, di cooperare con lui...".
Questo processo avrebbe potuto determinare "un mondo perfetto, nitido, incorrotto e incorruttibile" dove l'uomo era "condannato ALL'estasi". Dio non volle questo, "ha dipinto un quadro a metà... lasciando al fruitore il compito di integrare la sua opera, di cooperare con lui...".
"Coinvolto in una responsabilità creativa, non nella mera contemplazione del creato, il costume degli ebrei è ritmato sul tempo" e cita un autore che afferma: "i sabati sono le nostre grandi cattedrali".
Letta così tutta l'arte, tutta la cultura moderna, assumono valori non convenzionali e drammatici. Kafka, Soutine, Modigliani, Einstein, Freud, Schönberg, Mendelsohn, Chagall vivono e operano nell'ansia del tempo, nell'angoscia esistenziale dell'uomo sradicato che non ha luogo dove posare il capo.
E arriva a citare nell'ultima parte del discorso l'opera di Frank Lloyd Wright, il grande architetto americano, la cui opera è, per Zevi, il paradigma dell'architettura moderna. Questa opera rappresenta la vittoria del tempo, cioè l'incarnazione del pensiero ebraico.
E conclude il suo sondaggio, che chiama abbreviato e lacunoso, con questa definizione dell'architettura del maestro americano nella quale identifica il suo pensiero: "L'architettura di Wright... è multidimensionata, celebra lo spazio demolendone il feticcio e il tabù, cioè fluidificandolo, articolandolo secondo i percorsi umani, intessendo un continuum fra edificio e paesaggio...".
Terzo momento. La capacità di approfondimento e di interpretazione di quanto avveniva nel mondo dell'architettura fra il 1945 e il 2000 è dimostrata da Bruno Zevi nella sua produzione critica immensa (si pensi solo ai ventiquattro volumi Laterza di Cronache di architettura) e dalla puntualità della sua presenza sulla scena culturale e politica in ogni momento significativo della vita del paese.  Un segno distintivo di questo impegno è la continuità di pensiero che riuscì a creare, nell'arco di quasi cinquant'anni, fra la sua Storia dell'architettura moderna, che nel 1950 era già alla quinta edizione, e, l'altrettanto sua Controstoria dell'architettura che pubblicò in una serie di libri "millelire" a partire dal 1994 e che si concluderà nel 1998.
Un segno distintivo di questo impegno è la continuità di pensiero che riuscì a creare, nell'arco di quasi cinquant'anni, fra la sua Storia dell'architettura moderna, che nel 1950 era già alla quinta edizione, e, l'altrettanto sua Controstoria dell'architettura che pubblicò in una serie di libri "millelire" a partire dal 1994 e che si concluderà nel 1998.
Perché continuità? Perché uno dei principi della Controstoria è l'ottica a ritroso, "dal moderno all'antico" secondo una regola di ascendenza blochiana detta "del metodo regressivo", che Zevi descrive così: "non possiamo incarnarci negli uomini del IV secolo a. C. o del periodo barocco per investigare con i loro occhi...
Dobbiamo affrontare la sfida gioiosa di utilizzare i nostri occhi affrancandoli da anacronistici paraocchi. Ne discendono angolazioni critiche mirate...".
E non esita a fare i nomi dei sette "autentici architetti-poeti", dei "letterati prestigiosi" (fra i quali colloca Biagio Rossetti), delle figure "culturalmente incisive ma non convincenti sotto il profilo artistico", fino ai "personaggi nefasti". In Italia, dice Zevi, sono circa cento le opere che superano la prova della vera originalità espressiva, dalla preistoria alle soglie del 2000.
E conclude le pagine dedicate al perché di questa Controstoria con questa nota: "Lavoro da trent'anni per produrre una controstoria dell'architettura in Italia, un De Sanctis dell'urbatettura (urbanistica + architettura) che risulta tuttora assai inferiore al modello".
Mi pare di dover concludere questo "sondaggio breve e lacunoso" del pensiero del maestro con la desolata certezza che il 9 gennaio 2000, per la cultura architettonica del nostro paese, è iniziato un dopo Zevi di incerta prospettiva.




