La generazione degli immediati vincitori preferisce quindi ricorrere, non a caso, all'intonaco per tentare di cancellare segni della presenza storica degli avversari sconfitti ora vituperati, mentre chi viene molto tempo dopo, quando le passioni si sono in tutto o in parte placate, con più razionale distacco critico, sente la necessità di restituire alla società e ai suoi uomini ogni documentazione utile a una comprensione non mutilata e onesta del passato e dei suoi protagonisti.
Senza alcun corteggiamento ideologico e al di fuori delle indulgenze nostalgiche che talvolta la rilettura della storia può suggerire alle nuove generazioni (proprio qui a Ferrara il ripristino degli affreschi di Palazzo Schifanoia o delle tempere della Sala delle Muse del Provveditorato agli Studi non significarono certamente il ritorno al paganesimo e al culto dell'astrologia).
 Analogo discorso si può avanzare adesso - ma con qualche accresciuta preoccupazione per l'arco di tempo più ridotto - dinanzi agli affreschi di Mario Capuzzo che la Cassa di Risparmio di Ferrara ha deciso, dopo decenni, di restituire al suo autore e ai ferraresi, vincendo persistenti vocazioni censorie e i ricatti della retorica in cui si preferisce avviluppare la storia italiana e locale.
Analogo discorso si può avanzare adesso - ma con qualche accresciuta preoccupazione per l'arco di tempo più ridotto - dinanzi agli affreschi di Mario Capuzzo che la Cassa di Risparmio di Ferrara ha deciso, dopo decenni, di restituire al suo autore e ai ferraresi, vincendo persistenti vocazioni censorie e i ricatti della retorica in cui si preferisce avviluppare la storia italiana e locale.
Capuzzo, quasi alla fine dei suoi giorni, in un estremo disperato tentativo di ribellione verbale a quella che considerava "una palese e deprecabile violenza" contro una propria creatura artistica ("una violenza alla storia"), confidava con amara rassegnazione: "ormai dispero di rivedere i miei affreschi ...." (1).
Invece, a distanza di oltre venti anni, riceve un tardivo postumo risarcimento che, tuttavia - va ribadito per le vestali malinconiche del dogmatismo ideologico - non intende né può vulnerare l'autonomia di giudizio politico che appartiene a ognuno.
Né, va aggiunto per le vestali della critica estetica, la restituzione degli affreschi, di per sé, può costituire esaltazione sproporzionata del mondo pittorico di Mario Capuzzo che "è intimista, tardo romantico" (2). Al centro degli interessi dell'artista polesano restano paesaggi, fiori, barche, ritratti, allegorie e le riproduzioni antiche e non già l'epopea del fascismo e dei suoi interpreti.
 Qui, invece, nelle pareti dello scalone di Palazzo Koch, sede centrale della Cassa di Risparmio, chissà per quali ancora sconosciute ragioni, per la prima e ultima volta, Mario Capuzzo abbandona i temi prediletti e si cimenta con il mito della rivoluzione fascista e delle sue successive conquiste aeronautiche e coloniali con un lavoro a suo modo inizialmente encomiastico e celebrativo, secondo i desideri di una committenza di derivazione chiaramente balbiana.
Qui, invece, nelle pareti dello scalone di Palazzo Koch, sede centrale della Cassa di Risparmio, chissà per quali ancora sconosciute ragioni, per la prima e ultima volta, Mario Capuzzo abbandona i temi prediletti e si cimenta con il mito della rivoluzione fascista e delle sue successive conquiste aeronautiche e coloniali con un lavoro a suo modo inizialmente encomiastico e celebrativo, secondo i desideri di una committenza di derivazione chiaramente balbiana.
Dalla cronaca domestica, Capuzzo ora passa alla storia collettiva impegnativa ed esaltante, secondo i dettami del manifesto della pittura murale sottoscritto, qualche anno prima, tra gli altri, dal ferrarese Achille Funi e da quanti rendevano omaggio alla funzione sociale dell'arte nello stato fascista. È bene sottolineare che, in quel torno di tempo, il regime mussoliniano (come del resto quello comunista) si fece strenuo sostenitore dell'esistenza di un legame indissolubile e naturale fra la politica e l'arte.
Quello di Capuzzo, quindi, non fu un caso isolato. Proprio ultimamente Paul Ginsborg (3) ha sottolineato "la notevole accondiscendenza del mondo dell'arte nei confronti del regime". Al di là di una sorta di riconosciuto "ius murmurandi", infatti, tanti artisti - De Chirico, Balla, Carrà, Rosai, Martini, Campigli, Funi, Soffici e lo stesso Morandi - furono in definitiva fedeli al fascismo, così come lo furono, fra gli altri, poeti come Ungaretti e il copparese di Tamara Corrado Govoni (4). Per non parlare del mondo della scuola e dell'università (esemplare il caso di Norberto Bobbio).
 Nella logica celebrativa del tempo, perciò, non può destare alcuna meraviglia, in una periferia colta, dopo la morte di Italo Balbo nel giugno del 1940, la scelta di un tema naturalmente trionfalistico, sul quale era destinata ad abbattersi nel secondo dopoguerra tutta la violenza ideologica contraria all'esposizione ulteriore, ritenuta dannosa per la salute politica della città, dei più anziani come dei più piccoli.
Nella logica celebrativa del tempo, perciò, non può destare alcuna meraviglia, in una periferia colta, dopo la morte di Italo Balbo nel giugno del 1940, la scelta di un tema naturalmente trionfalistico, sul quale era destinata ad abbattersi nel secondo dopoguerra tutta la violenza ideologica contraria all'esposizione ulteriore, ritenuta dannosa per la salute politica della città, dei più anziani come dei più piccoli.
Erano del resto, quelli, gli anni del consenso in cui un antifascista della prima ora, morto tragicamente in un campo di sterminio tedesco, Francesco Viviani, collaborava al Corriere padano, inviando, fra l'altro, corrispondenze entusiastiche dalla Libia ("l'apparizione delle tragedie di Euripide sulle scene marmoree del teatro di Sabratha prova, ancora una volta, quale sia la potenza civilizzatrice d'Italia, la quale non accontentandosi di riportare al sole, contendendoli alle sabbie secolari, i monumenti di Roma imperiale per il suo e per gli altri popoli, lancia nel cuore degli uomini e nello spazio infinito, tra il deserto e il mare, il grido di bellezza della Grecia imperitura"). (5)
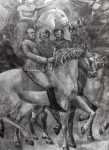 È stato osservato recentemente che "se a Sironi togli il fascismo, di Sironi non si capisce più niente", perché nell'ideologia composita del movimento fascista c'è posto per l'orgoglio e la missione nazionale, e per lui il fascismo non è la guardia bianca del capitale e della reazione (6). Ora qualcosa del genere, nonostante le differenze stilistiche, si può dire a proposito di questi affreschi di Mario Capuzzo: il suo fascismo è in realtà una sorta di socialismo, magari filtrato dalla pascoliana "grande proletaria" italiana che finalmente si era mossa proprio con l'avventura tripolina del 1911, ormai vittoriosa con Italo Balbo.
È stato osservato recentemente che "se a Sironi togli il fascismo, di Sironi non si capisce più niente", perché nell'ideologia composita del movimento fascista c'è posto per l'orgoglio e la missione nazionale, e per lui il fascismo non è la guardia bianca del capitale e della reazione (6). Ora qualcosa del genere, nonostante le differenze stilistiche, si può dire a proposito di questi affreschi di Mario Capuzzo: il suo fascismo è in realtà una sorta di socialismo, magari filtrato dalla pascoliana "grande proletaria" italiana che finalmente si era mossa proprio con l'avventura tripolina del 1911, ormai vittoriosa con Italo Balbo.
Al centro della sua pittura, a ben vedere, e al di là delle apparenze, non c'è l'epopea del fascismo trionfante, ma ancora la tribolazione, la sofferenza, e la fame dei poveri, una lontana eco, forse, della lezione umanitaria di Giuseppe Mentessi.
Incontro occasionale, quindi, con il regime fascista, ma senza dimenticare gli umili, gli oppressi e l'ansia verso un avvenire più ordinato e promettente: è questa una possibile lettura di due affreschi (che misurano ciascuno 7 metri di lunghezza e 4 metri e mezzo di larghezza): uno spazio appena sufficiente per descrivere il mito moderno di Ferrara, dalla marcia su Roma sino alla trasvolata atlantica e la colonizzazione della Libia, proprio a distanza di poco tempo dall'affabulatorio più vasto racconto storico-letterario sul mito di Ferrara portato a termine nella Sala dell'Arengo da Achille Funi.
Qui, Capuzzo è crepuscolare e dolente, soprattutto nel primo affresco, quello posto a sinistra, e di cui, per pudore o reticenza, nessuno aveva mai parlato prima dello scoprimento di questi mesi (e che forse aveva determinato il prolungato intervento censorio complessivo).
 In questa pittura viene raccontata, con vulgata ferrarese, l'inizio della "rivoluzione", con i caduti fascisti del 20 dicembre 1920 sotto il Castello, e la conclusione raggelata della marcia su Roma, con Mussolini e i quadrumviri a cavallo, quasi riluttanti e forse presaghi di un destino tragico ormai imminente, nel 1940 e nel 1941. Crepuscolari della rivoluzione, collocati lì, quasi a esprimere una tristezza esistenziale dinanzi alla storia che passa.
In questa pittura viene raccontata, con vulgata ferrarese, l'inizio della "rivoluzione", con i caduti fascisti del 20 dicembre 1920 sotto il Castello, e la conclusione raggelata della marcia su Roma, con Mussolini e i quadrumviri a cavallo, quasi riluttanti e forse presaghi di un destino tragico ormai imminente, nel 1940 e nel 1941. Crepuscolari della rivoluzione, collocati lì, quasi a esprimere una tristezza esistenziale dinanzi alla storia che passa.
Nulla di eroico o travolgente: madri in lacrime, commilitoni in posa, una corona d'alloro, gagliardetti e saluti romani. Ma ciò che più impressiona è la malinconia disegnata sui volti di Mussolini, Balbo, De Vecchi, De Bono e Bianchi, riuniti, al di là di ogni verosimiglianza storica, proprio il 28 ottobre 1922, quando invece si trovavano a Milano, a Perugia o nella campagna romana.
I cinque cavalli che li sorreggono, privi di slancio, concitazione e ritmo, come invece la situazione storica richiederebbe, sembrano percepire la tragedia dei rivoluzionari riluttanti, persi ciascuno nei propri pensieri oppure colti in un momento in cui il pensiero è totalmente assente!
 La memoria, comunque, corre a un'altra marcia su Roma, quella di Giacomo Balla riscoperta con la recente mostra Novecento. Arte e Storia in Italia, colpita anch'essa in seguito dalle riserve ideologiche sul soggetto (7).
La memoria, comunque, corre a un'altra marcia su Roma, quella di Giacomo Balla riscoperta con la recente mostra Novecento. Arte e Storia in Italia, colpita anch'essa in seguito dalle riserve ideologiche sul soggetto (7).
È probabile che Capuzzo abbia visto a Roma, dopo il 1935, questo quadro e che l'abbia tradotto, con le risorse di cui disponeva e con il suo personale temperamento, qualche tempo dopo. E, qui, infatti, la cifra stilistica è assai diversa: gli uomini, una trentina in tutto, guidati da Mussolini e dai quadrumviri, sono a piedi e, come scrisse lo studioso Alfredo Silvestri, "pare s'avanzino ed escano dal dipinto trasportati dall'ansia di ricondurre al Re soldato la vittoria ch'ebbe in un primo tempo tarpate le ali !"
Invero, per Capuzzo la pittura non soggiace alle pretese della storia e il suo affresco rende possibile all'osservatore perfino un'interpretazione soggettiva. Come del resto si può notare nell'altro affresco, quello di destra, abbastanza mosso, con tanta gente operosa tra bandiere, gagliardetti, cammelli, aeroplani, palme, officine, case coloniche, soldati italiani e indigeni, littori di colore, e monumenti senza precise inquadrature spaziali.
 C'è, qui, un particolare modo di assemblare ricordi, appunti, elementi della cronaca, suggerimenti e suggestioni. Domina la scena, a cavallo, il governatore Italo Balbo che osserva quelle genti affaticate che, però, chiaramente, non si accorgono di lui. Anche qui si può cogliere, qua e là, forse un ricordo dell'affresco di tipo commemorativo nel Palazzo del Governo a Tripoli, portato a termine in breve tempo da Achille Funi, nel 1937 (8), e qui tradotto senza eccitazione retorica sovrabbondante (9).
C'è, qui, un particolare modo di assemblare ricordi, appunti, elementi della cronaca, suggerimenti e suggestioni. Domina la scena, a cavallo, il governatore Italo Balbo che osserva quelle genti affaticate che, però, chiaramente, non si accorgono di lui. Anche qui si può cogliere, qua e là, forse un ricordo dell'affresco di tipo commemorativo nel Palazzo del Governo a Tripoli, portato a termine in breve tempo da Achille Funi, nel 1937 (8), e qui tradotto senza eccitazione retorica sovrabbondante (9).
I due dipinti capuzziani, prima per evidenti ragioni belliche e in seguito per motivi legati all'epurazione del dopoguerra, ebbero, come si vede, vita effimera in città, tanto che in parte se n'era persa la memoria, anche per ragioni legate a comprensibile censura. Ora, invece, Capuzzo può godere di un tardivo risarcimento per la sua creatura ritrovata, mentre la città, che ancora si accende per l'intitolazione di una strada, può ripensare la propria storia con questo frammento che le viene restituito per una comprensione più vasta, nel segno comunque di una democrazia più matura.
Note
1. Carlo Teodori, Mario Capuzzo, Verona 1980, 17.18
2. Angelo Andreotti,"Mario Capuzzo. La pittura come mestiere" - Catalogo della Mostra del 1998 presso le Civiche Gallerie d'arte Moderna e Contemporanea.
3. P. Ginsborg, "Storia ed arte nell'Italia del XX secolo", in Novecento - Arte e Storia in Italia, Roma 2000
4. C. Govoni, Poema di Mussolini, 1938 Roma.
5. F. Viviani, "Voce dell'Ellade nell'Africa Romana. Euripide al teatro di Sabratha", Corriere Padano - 8 Aprile 1938.
6. Stenio Solinas, "Quando la pittura vuol fare piazza pulita", Il Giornale, 7 gennaio 2001.
7. Il quadro, un olio su tela di cm. 260 x cm. 332, costituisce il verso di un altro quadro di Balla ("Velocità astratta") del 1913. Nuocciono alcune imprecisioni del catalogo. Nella scheda della"Marcia su Roma" si legge che Giuseppe Bottai diventerà Ministro della Cultura popolare (e non dell'Ed. Nazionale); si fa riferimento ad una improbabile foto d'epoca ufficiale come fonte di ispirazione del quadro. Lo stesso Ginsborg nella nota 59 di pg. 60 sostituisce un inconfondibile Italo Balbo con Dino Grandi divenuto così quadrumviro.
8. Lucio Scardino, "L'officina ferrarese IN Libia: Funi e gli altri", pagg. 289 - 301, in Gresleri G. - Massaretti P.G. - Zagnoni S. (curatori), Architettura italiana d'oltremare 1870 - 1940, Venezia.
9. Notizie sui due affreschi si ritrovano in un articolo apparso sul Corriere padano del 12 settembre 1940 ("Egli intende celebrare, IN questi affreschi, il fascismo ferrarese e il suo Capo."). Manca, nonostante la previsione dell'articolista, "l'apoteosi fiammeggiante per la quale la vita tramutata da una fiamma ha lanciato l'anima nei cieli della gloriosa immortalità". Ancora nel 1941 il lavoro di Capuzzo non era terminato: in una lettera del 3 maggio 1941 il Direttore della Cassa, Luigi Calzolari, segnalava all'artista l'esigenza, manifestata dal Presidente Sen. Arlotti, di togliere come significato centrale dell'arrivo della crociera aerea la statua della libertà di New York, e di sostituirla con il monumento a Cristoforo Colombo.




